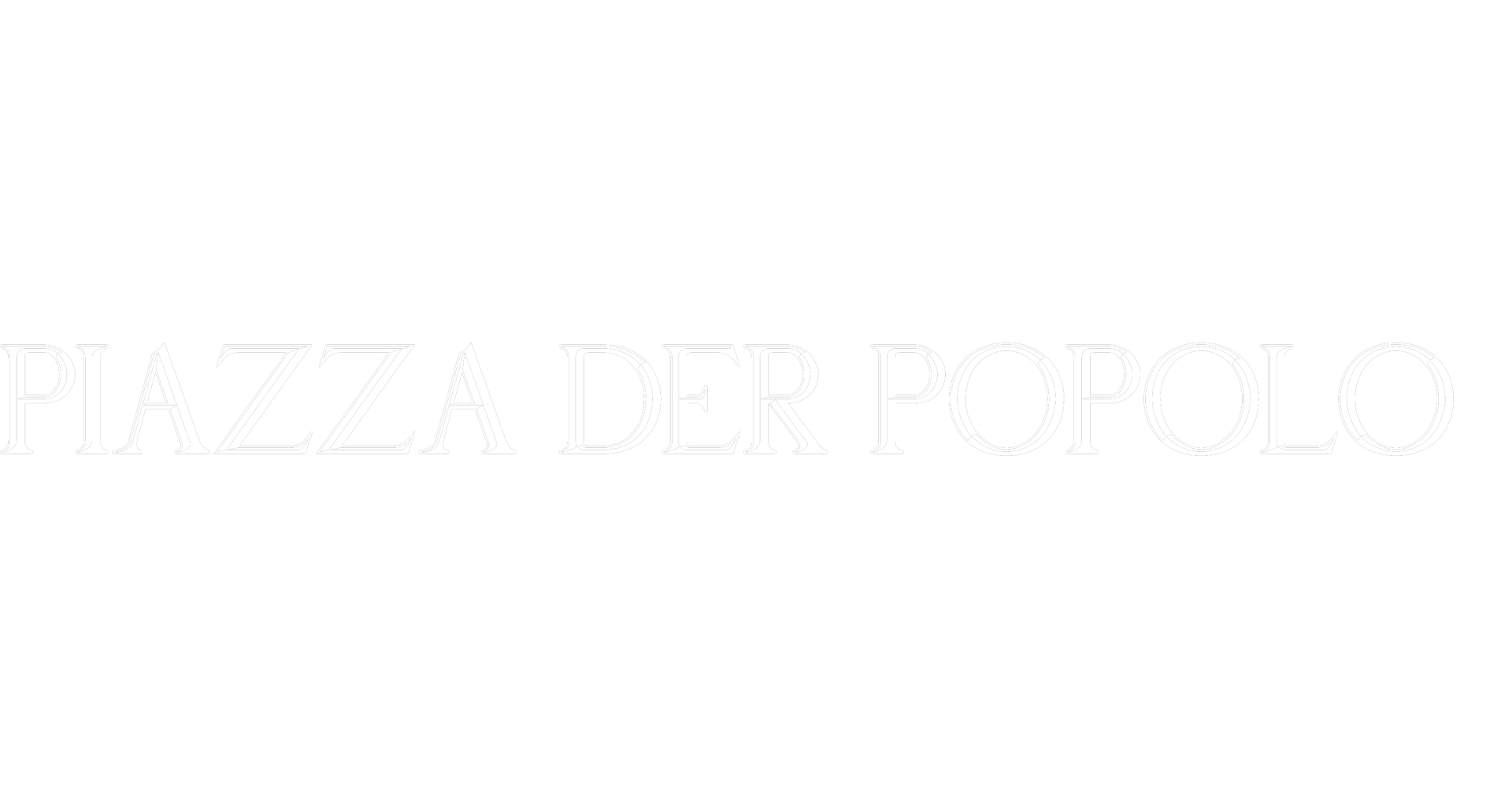L'ELEGANTE ROMANITÀ DI MARIA BEATRICE di Claudio Di Giampasquale

Nel 1923 lo scrittore giornalista fiorentino Aldo Valori si trasferì nella città eterna per dirigere l'ufficio romano del «Corriere della Sera». Trovò ottima sistemazione in uno degli eleganti quartieri umbertini della Roma bene e così portò con sè la famiglia composta da sua moglie Etre Maria Rontini scrittrice di favole e libri per bimbi e dai loro quattro figli, il tredicenne Francesco e i piccoli Luigia di sette, Paolo di quattro e Michele di pochi mesi. Valori era noto all'epoca anche come esperto nella comunicazione di questioni storiche militari, ed oltre ad aver pubblicato tanti saggi, per anni aveva scritto di questioni di geopolitica su la «Nazione» e sul «Resto del Carlino».
Dopo meno di quattro anni, nacque a Roma la quinta e ultima erede dell'apprezzata coppia di intellettuali, venerdi 13 maggio 1927 venne alla luce la piccola e vispa Maria Beatrice.
Pur accettando di prendere la tessera fascista, Aldo Valori ebbe con il regime un rapporto sempre distaccato, imparziale e diffidente. Nel 2003 la Editori Riuniti di Roma ha pubblicato il libro Aldo Valori. Il fascista che non amava il regime, curato da Valentina Tonelli Valori, con la prefazione di Sergio Romano.
Maria Beatrice, per brevità, venne poi chiamata Bice in famiglia, e così al di fuori. La piccola trascorse un’infanzia serena in un ambiente alto-borghese circondata dall'affetto di papà e mamma, dei suoi fratelli e delle tate, nella loro bella casa romana. Benchè sentisse frequentemente dialettare i genitori in toscano e fosse ogni estate allietata da lunghe villeggiature al mare a Castiglioncello vicino Livorno, il nascere e crescere all'ombra dei sette colli fece pian piano metabolizzare alla bimba la mentalità, l'ironia e le convenzioni culturali tipiche romane. La sua città le formò sin dai primi anni di vita quel suo carattere schietto, dolcemente aggressivo e canzonatorio, che la rese tanto amata quando da adulta scelse la sua strada.
L'anno prima dell'entrata in guerra dell'Italia, Maria Beatrice s'iscrisse al prestigioso liceo Ennio Quirino Visconti a piazza del Collegio Romano, ove più d'ogni altra scuola, in quel periodo, era fresca la ferita discriminatoria delle “leggi razziali” sulla scuola italiana. Il Visconti era frequentato fin dalla sua fondazione da molti ebrei della comunità romana, nel 1938 l'anno precedente che vi entrasse Bice, cinquantotto studenti e un’insegnante erano stati espulsi solo perché ebrei. Era un periodo terribile per la nazione, anni bui, anche in quell'istituto scolastico si respirava aria pesantissima, Bice durante la frequentazione la respirò tutta. Lunedì 10 giugno 1940 Benito Mussolini dal balcone di palazzo Venezia annunciò l'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania. Seguirono gli anni degli orrori.
Maria Beatrice cercando di non abbattersi per le enormi difficoltà che gradualmente, come tutti i romani, coinvolsero anche la sua famiglia, si gettò anima e cuore negli studi e proprio nei momenti più tragici e drammatici della città caduta sotto il giogo dei nazisti, s'accinse al difficile anno della maturità che conseguì con successo nove mesi prima della liberazione di Roma da parte delle forze alleate.

Immediatamente dopo la fine del conflitto, Maria Beatrice si iscrisse, dietro forte pressione dei genitori, alla facoltà di lettere dell'università della «Sapienza», ma lo fece controvoglia, lei sentiva dentro di sè un'altro richiamo per il suo futuro e questa sua diversa convinzione non le fece ottenere nessun risultato in facoltà, al punto che riuscì a convincere prima sua madre e di conseguenza anche papà Aldo ad iscriversi all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e lì si ritrovò immediatamente nel suo ambiente naturale. Si diplomò a pieni voti nel 1948. In Accademia la giovanissima attrice conobbe Paolo Panelli, di due anni più grande e con il quale si instaurò immediatamente un'incredibile intesa che divenne per ambedue una fortuna nonché un lungo e proficuo sodalizio sia artistico che d'amore. Si sposarono e dal loro matrimonio, celebrato nel 1952, nacque Daniele che morì in tenera età, e nel 1957 Alessandra, divenuta anch'essa attrice, oltreché regista e docente.

Bice Valori fu impegnata dapprima in radio, dove tra il 1949 e il 1951 entrò nella celebre rivista radiofonica «La Bisarca» di Pietro Garinei e Sandro Giovannini quindi fu reclutata nella Compagnia del teatro comico musicale di Radio Roma.
Nel teatro di prosa lavorò, sia pure in modo saltuario, con registi importanti, come Orazio Costa, che la utilizzò al tempo del teatro Stabile di Roma in particolare con Panelli in «Don Giovanni» di Molière nel 1949. Poi in «L’invito al castello» di Jean Anouilh, in «La leggenda di Liliom» di Ferenc Molnár e in «La dodicesima notte» di Shakespeare nel 1950.
A partire dai primi anni cinquanta, l'attrice cominciò a lavorare con successo nel teatro di rivista. Tra i numerosi spettacoli si ricordano «Controcorrente» nel 1953, «Senza rete» e «Oh quante belle figlie madama Doré» con l'amico Walter Chiari nei due anni successivi. Il vero successo arrivò però grazie alla televisione e con la partecipazione anche a diversi sceneggiati. Sia da sola che insieme al marito Paolo Panelli. Bice Valori fu protagonista di numerosi lavori televisivi e radiofonici, quasi sempre di genere brillante. Nel 1964 prese parte alla celeberrima miniserie Rai «Il giornalino di Gian Burrasca» sceneggiata e diretta da Lina Wertmüller, ove interpretò la tirannica direttrice del collegio in cui viene mandato il protagonista, interpretato da Rita Pavone. Bice pesantemente truccata, impersonava una donna di bassissima statura, e dovette perciò recitare sempre in ginocchio. Fu un'interpretazione da fuoriclasse apparentemente seria ma sotto sotto ironica e brillante.
La Valori inoltre fu una straordinaria intrattenitrice in famosi varietà anche negli anni seguenti, come «Doppia coppia» a cavallo degli anni sessanta e settanta, in cui tra le varie qualità artistiche si distinse soprattutto per l'esilarante siparietto del personaggio della centralinista spoletina della Rai, rimasto ancora nella memoria del pubblico. «Speciale per noi» nel 1971 insieme a Paolo Panelli, Aldo Fabrizi e Ave Ninchi, e, dopo un'assenza di qualche anno per vari impegni teatrali «Ma che sera» nel 1978 condotto da Raffaella Carrà. L'ultima apparizione televisiva risale al 12 gennaio 1980 sempre in coppia con Paolo Panelli, nella prima puntata di «Giochiamo al varieté», nello sketch più volte replicato del tassista e della cliente.
Notevoli e acclamate le sue partecipazioni alle commedie musicali firmate ancora da Garinei e Giovannini, tra cui «Rugantino» nel 1962 con Nino Manfredi e Aldo Fabrizi e le due fortunate produzioni, cui prese parte anche il marito Paolo Panelli di «Aggiungi un posto a tavola » nel 1975 e «Accendiamo la lampada».
Nel 1978 venne nuovamente inserita nel cast di Rugantino, interpretato stavolta da Enrico Montesano, con il medesimo ruolo della sorella Eusebia.
Tante le sue partecipazioni anche al cinema sin dal 1950, tra cui si segnalano in particolare quelle ai film, entrambi di grande successo, «La bisbetica domata » di Franco Zeffirelli nel 1967 ove impersonò una vedova.
«Il medico della mutua» di Luigi Zampa nel 1968 ove interpretò con intelligenza e sottile ironia il ruolo di Amelia Bui, moglie non più giovanissima e insoddisfatta d'un medico primario moribondo, e nella quale in varie scene riesce a tenere saldamente testa anche al protagonista Alberto Sordi, notoriamente poco incline a lasciare troppo spazio ad altri attori nei propri film.
Riapparve in un film di soggetto "ospedaliero" e con il ruolo di un medico in «Gli infermieri della mutua» di Giuseppe Orlandini nel 1969. Fu molto amata dal pubblico, forse meno rispettata dalla critica.
Per le conseguenze d'un improvviso tumore se ne andò lunedi 17 marzo 1980, cinque mesi dopo suo fratello Michele, aveva solo cinquantadue anni. Le sue spoglie riposano al cimitero Flaminio a Roma.