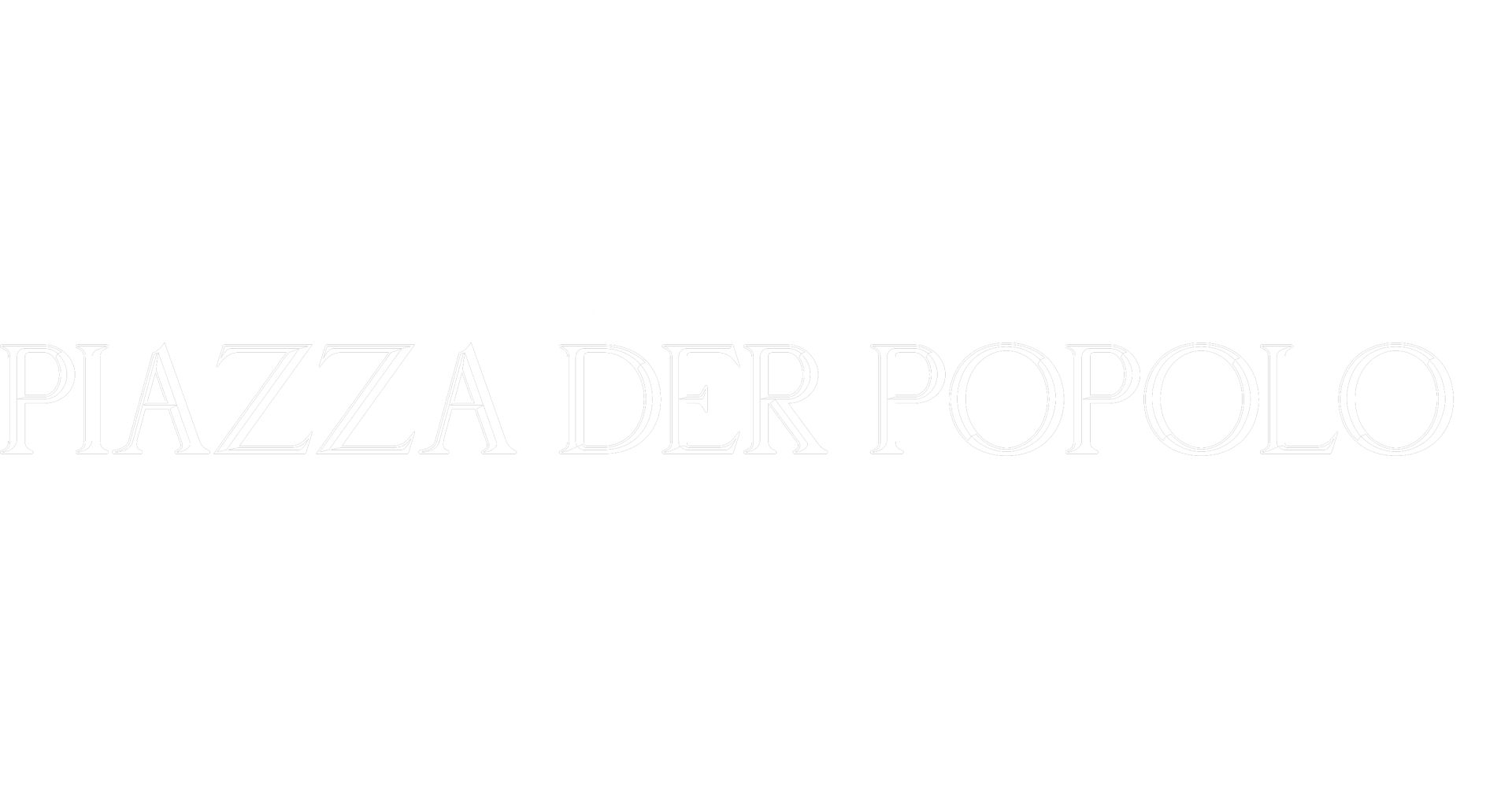IL MAGNIFICO CAFFÈ ARAGNO AL CORSO di Claudio Di Giampasquale
Ci sono luoghi che conservano ricordi sedimentati nell’immaginario cittadino perché evocano una particolare atmosfera e una storia memorabile; sono luoghi con un’anima. A Roma uno di questi fu (ed è rievocato ancora oggi nelle testimonianze e nelle immagini d'epoca) il mitico «Caffè Aragno» a pochi passi dai "palazzi del potere". Non fu solo un caffè, ma un luogo d'ispirazione della borghesia, caratterizzato da un'atmosfera d'ottimismo, progresso e prosperità culturale. Divenne territorio di culto degli intellettuali. Di esso si conservano ormai solo reminiscenze. Era al civico 180 di via del Corso, a "palazzo Marignoli", e raggiunse il massimo splendore negli anni Trenta, quando a frequentarlo furono eccelsi artisti di fama nazionale e internazionale.
Ma partiamo dalle origini. Lo scenario é nel contesto storico dei primi anni dello scorso secolo, quando il centro di Roma, divenuta da tre lustri capitale del Regno d'Italia, stava gradualmente divenendo punto d'incontro d'interessi politici, finanziari ed economici, di conseguenza crocevia di una marea di persone, sia residenti nell'urbe stessa che provenienti da ogni dove.
Per questi motivi, il fulcro della nuova capitale divenne nell'immaginario degli intraprendenti uomini d'affari un vero e proprio eldorato, ossia luogo ideale ove osare investire. Uno di costoro che ebbe l'audacia di fare il grande salto fu un certo Giuseppe Aragno, rampollo di una famiglia piemontese, proprietaria di eleganti caffetterie e pasticcerie a Torino, Cuneo e Mondovì. Giuseppe era giovane e intraprendente, voleva tracciarsi una strada per conto suo, proprio a Roma una città che lo aveva affascinato e stregato sin da subito per la sua straordinaria bellezza. Era molto intelligente, acuto e rapido nelle scelte, aveva una visione nuova. Gli Aragno erano imprenditori con esperienza nel settore, lui, "sul campo", aveva assorbito e metabolizzato tutte le competenze e le necessarie perizie per coltivare l'ambizione d'aprire un locale in autonomia lontano da casa. E poi, oltre al coraggio e alle misurate risorse economiche che la famiglia gli mise a disposizione, i volori aggiunti del suo progetto furono l'entusiasmo, la passione per la croissanteria, la pasticceria e la caffetteria. Ma soprattutto, per le arti e la cultura, in ogni forma. Nel 1886 si stabilì in pianta stabile nella capitale, trovò alloggio in via dell'Arco della Ciambella nel rione Pigna, iniziando un'accurata perlustrazione per trovare il locale giusto dove aprire la sua attività.
Nel frattempo continuava a elucubrare. Il suo desiderio e obiettivo fu quello d'affermare nella città eterna a suo modo una "caffetteria letteraria" che fosse almeno alla pari del "Caffè Greco" in via dei Condotti e del "Caffè Canova Tadolini" in via del Babuino, ma con qualcosa in più. Voleva creare qualcosa di nuovo, un luogo di ritrovo e scambio culturale, seguendo le tendenze del periodo e le mode dell'epoca.
Giuseppe aveva girato tutta l'Europa per "acculturarsi sulle tendenze internazionali". I suoi modelli preferiti erano il "Caffè Le Procope" a Parigi; il "Caffè Gijón" a Madrid; "A Brasileira" a Lisbona; "The Elephant House" a Edimburgo; il "Caffè Tommaseo" a Trieste; il "Caffè Florian" a Venezia e il "Gambrinus" a Napoli. Era molto esigente, dopo tanto cercare tramite passa parola, trovò il locale, era in via del Corso al civico 300 nell'appena restaurato "Palazzo Verospi Vitelleschi" situato tra il "Palazzo Bonaparte" e il "Palazzo Doria Pamphilj" assai ben posizionato dal punto di vista commerciale. Benchè ci fosse molto passaggio, era troppo lontano dai palazzi del potere: Montecitorio, Palazzo Chigi e piazza del Parlamento, il centro della mondanità romana era attorno a Piazza Colonna. Eppoi non era grande come avrebbe voluto, tuttavia aveva cinque vetrine d'entrata ma con una "luce" non ampia come desiderava. Ma aveva atteso troppo, doveva "partire" col suo progetto imprenditoriale. Per gli arredi incaricò lo stesso architetto Luigi Tedeschi che aveva restaurato l'intero palazzo edificato nel 1580 dalla famiglia Vitelleschi, passato poi alla famiglia Tassi ed infine alla famiglia Verospi.
In soli tre mesi la prima versione romana del «Caffè Aragno» aprì i battenti. Fu un grande successo, gli avventori arrivavano a frotte, bella gente, principalmente benestante, tuttavia non era il target che Giuseppe voleva. Come tutti gli uomini di successo, aveva le idee molto chiare e sebbene gli affari andassero a gonfie vele, sentiva che non era nella direzione che si era prefissato.
Dopo soli tre anni si liberarono i meravigliosi locali su strada del prestigioso Palazzo Marignoli a pochissimi passi dalla zona più influente di Roma, sia nelle dimensioni che nel posizionamento era la soluzione che sognava. Non perse l'occasione. Non lesinò in economia, nella scelta del progettista dei preziosi arredi che aveva in mente, nello stile architettonico del locale e nella preziosità dei materiali per le stigliature.
Incaricò per la progettazione e la direzione dei lavori l'esimio architetto romano Giulio Podesti che quindici anni addietro aveva fondato il
"Circolo tecnico d'ingegneri, architetti e agronomi". Il risultato fu uno spettacolo, il grande Caffè venne ripartito in diverse lussuose "salette" in stile "Art Nouveau", con lesene, grandi specchiere, porte architravate, soffitti a cassettoni e volte affrescate. E così il mitico «Caffè Aragno» aprì i battenti, venne inaugurato venerdi 14 marzo 1890 con la presenza della più prestigiosa borghesia romana. Ben presto fu frequentato da letterati e pittori, ma anche da deputati e ministri, che venivano dalla vicina Camera dei Deputati, diventando in poco tempo centro non solo della mondanità, ma anche della cultura romana.
Nei primi anni del Novecento vi si riunirono
"i letterati della terza saletta", tra cui Vincenzo Cardarelli, Roberto Bracco, Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Antonio Baldini, Filippo Tommaso Marinetti, Anton Giulio Bragaglia, Mario Pannunzio, Leonardo Sinisgalli, e Pirandello. I critici d'arte furono Emilio Cecchi e Roberto Longhi, inoltre erano presenti architetti come Cesare Bazzani e altri artisti. La terza saletta fu decorata, nel 1923, con pitture di Giuseppe Cherubini, che presero lo spunto da episodi risorgimentali e della Prima Guerra Mondiale, era costituita da undici pannelli.
Il 14 novembre nel 1906 scoppiò una bomba all'esterno del Caffè Aragno, l'attentato aveva una matrice anarchica, per fortuna non ci furono né morti né feriti gravi.
Il dipinto di Amerigo Bartoli Gli amici al caffè (1930, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna) è una sorta di "foto di gruppo" in cui ritroviamo molti degli esponenti dell’ambiente culturale e artistico: Emilio Cecchi, Vincenzo Cardarelli, Carlo Socrate, Ardengo Soffici, Antonio Baldini, Pasqualina Spadini, Giuseppe Ungaretti, Mario Broglio, Armando Ferri, Quirino Ruggeri, Roberto Longhi, Riccardo Francalancia, Aurelio Saffi, Bruno Barilli, oltre allo stesso Bartoli e all'imperturbabile cameriere Malatesta. In quel momento, tuttavia, il caffè cominciava a diventare il simbolo di una generazione da superare: Scipione (su "L'Italia Letteraria", 5.10.1930) fa la caricatura del quadro di Bartoli, sfottendo Cecchi, Cardarelli, Socrate, Soffici, Baldini, Pasqualina Spadini, Ungaretti, Broglio, Fetri, Ruggeri, Longhi, Bartoli, Barilli . "Quelli di Aragno", come li chiama Mafai, appaiono come personaggi un po' appannati, con l’eccezione di Giuseppe Ungaretti e di pochi altri.
L'intellettuale scrittore e giornalista Orio Vergani descrisse il «Caffè Aragno» sul Corriere della Sera con queste testuali parole: «Il Caffè Aragno su via del Corso è luogo d'incontri favorito per i primi trent'anni del secolo, la sua famosa "terza saletta" è il "sancta sanctorum della letteratura, dell'arte e del giornalismo"».
Lo scrittore Adone Nosari nella sua opera
"Storia culturale Italiana del 900"
scrisse nel 1928 a proposito della terza "Saletta d'Aragno":
«Vi si ritrovano gli artisti già affermati e d'avanguardia, avvengono le più scottanti discussioni sull'arte: vede il tempo eroico del futurismo e poi il "ritorno all'ordine", si dibattono le idee di "Valori Plastici" e de "La Ronda", le opposte visioni del classicismo e dell'espressionismo. Il locale, sempre saturo del fumo degli avventori, ha le pareti color tabacco, con grandi specchiere e due finestre che si aprono su via delle Convertite; alle pareti corre un lungo divano foderato di tela,con una trentina di tavoli in ferro col ripiano di marmo. "La sala , un po' alla volta, si riempiva. Oppo calava dal suo studio fuori porta e sedeva al tavolo di Spadini, che non abbandonava mai la sciarpa di lana e il bastone cui aveva dato il nome vezzeggiativo di Gelsomino. Ecco Vincenzo Cardarelli, Barilli e Antonio Baldini col primo numero della "Ronda". Di cosa parlavano, a bassa voce, come congiurati? Parlavano di Leopardi, il primo dei "Convitati di pietra". Laggiù in fondo, dietro ai velari di fumo, tempestava , col cappello duro buttato sulla nuca, F. T. Marinetti, e Bragaglia coi baffetti a virgola, annunciava la prossima apertura del Teatro degli Indipendenti, con una novità di Pirandello che’era entrato in quell'istante».
IL DECLINO E LA CHIUSURA
Con l'inizio del Ventennio fascista il caffè iniziò a perdere gradualmente la sua centralità culturale, segnando la fine di un’epoca. In un’era di cambiamento in cui le avanguardie artistiche cedevano il passo a nuovi movimenti culturali, il Caffè Aragno divenne il simbolo di una generazione da superare. L’artista Mario Mafai, con la sua pungente satira, ironicamente descrisse “quelli di Aragno” nella sua caricatura del quadro di Bartoli: era il 1929, Mafai insieme a Scipione e Antonietta Raphaël, aveva appena fondato il gruppo artistico noto come "Scuola di via Cavour", che segnò una svolta nell'arte romana, allontanandosi dalle tendenze novecentiste in voga nelle blasonate salette del Caffè in via del Corso e avvicinandosi a un linguaggio più espressionista
E così gli intellettuali e gli artisti dell'Aragno iniziarono ad apparire come figure un pò appannate, con l’eccezione di Giuseppe Ungaretti e pochi altri. Dopo il delitto Matteotti, Giuseppe Aragno, socialista ed ex amico di Mussolini, manifestò ostilità al regime fascista e lasciò Roma, finendo i suoi giorni negli Stati Uniti. Il prestigioso locale fu diretto dai familiari di Giuseppe, scesi dal Piemonte a Roma: la nipote Giulia e suo marito Giovanni Peroni presero le redini dell'attività. Furono bravissimi nella gestione ed entrarono subito in empatia con i dipendent e con i clienti. Ma senza Giuseppe Aragno non fu più la stessa musica.
Nonostante la perdita di centralità, il Caffè Aragno rimase un punto di riferimento per la memoria collettiva e un segno tangibile del passato glorioso. La sua eredità culturale è stata tramandata attraverso non poche testimonianze storiche e la memoria collettiva di una generazione passata. Ancora oggi, nel terzo millennio, la memoria del Caffè Aragno continua ad essere un simbolo indelebile della Roma d’avanguardia e un prezioso tassello del patrimonio culturale della città eterna, ispirando e affascinando coloro che apprezzano la storia e la vitalità di questa meravigliosa città.
I cambiamenti sostanziali del grande spazio in via del Corso avvennero pochi anni dopo che l'Italia divenne una repubblica. Nel 1951, furono sottoposti a importanti lavori di trasformazione progettati dall’architetto Attilio Lapadula. Trascorsero ulteriori quattro, nel 1955, il mitico Caffè Aragno fu ceduto alla società Alemagna Spa di Melegnano (fondata nel 1921 da Gioacchino Alemagna) che operava nel settore dolciario e della ristorazione, di conseguenza chiuse definitivamente i battenti, cedendo il passo al "Caffè Alemagna"
che nel 1977 entrò a far parte del gruppo Autogrill Spa, in seguito alla fusione dei "nordici" marchi Alemagna, Motta e Pavesi. Negli anni ’90 il grande locale fu trasformato in uno Spizzico. Nel 2014 il locale fu definitivamente chiuso e i dipendenti ricollocati altrove.
Dal 27 maggio 2021, quella che fu la storica sede del Caffè Aragno ospita un Apple Store.
Nonostante le trasformazioni, alcuni elementi artistici originali sono stati preservati. Durante i lavori di ristrutturazione per l’apertura dello store informatico, sono stati accuratamente restaurati e reintegrati nel nuovo design diversi pannelli di graffiti creati dal pittore Afro Basaldella nel 1950, oltre agli affreschi
“Alba”
di Fabio Cipolla e
“Crepuscolo”
di Ettore Ballerini, risalenti ai primi anni del 1900.