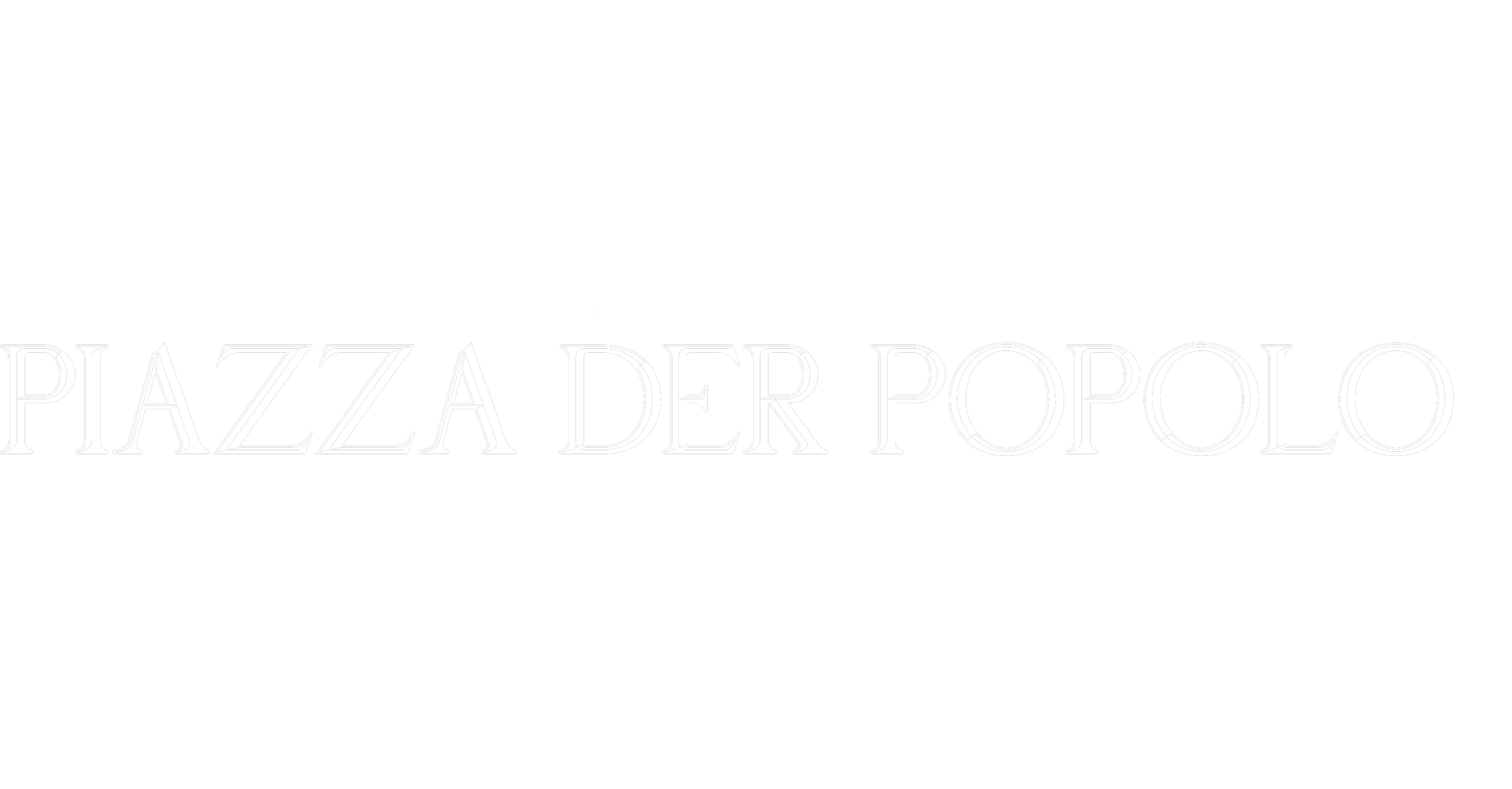LA "BELLA EPOQUE" ROMANA di Claudio Di Giampasquale
Dopo che Roma divenne di fatto capitale, il commercio iniziò a operare sotto le leggi del Regno d'Italia le quali promuovevano l'instaurazione di un'economia di libero scambio che permettesse una svincolata circolazione di merci, servizi, capitali e manodopera a livello nazionale, con l'obiettivo di modernizzare il paese e competere con le potenze europee. La città eterna in quell'epoca non aveva regole mercantili adatte al nuovo ruolo, il sistema dello scambio delle merci esisteva ancora principalmente secondo le leggi e i regolamenti pontifici, con un'economia principalmente agricola e qualche attività artigianale.
In sostanza, Roma ancora non possedeva l'infrastruttura e gli apparati amministrativi adatti ad essere il baricentro commerciale del Regno d'Italia. Fu la prima legge per l'adeguamento urbanistico insieme ad altri interventi normativi successivi che permisero l'avviamento d'un lungo processo di riorganizzazione del commercio romano che partì dall'inizio del Novecento crescendo e sviluppandosi vorticosamente, ma assai confusamente, dall'inizio del secolo sino alla metà degli anni '30, insomma sin quando entrò in auge e s'affermò il concetto di «terziario» come ramo distinto dell'economia per far ordine e distinguere il commercio, il turismo, l'artigianato, i servizi d'ogni genere, i trasporti e le comunicazioni, dagli altri due settori «primario» e «secondario»
comprendenti l'agricoltura, allevamento, l'industria e la produzione in serie di materiali tangibili. Col grande sviluppo del sistema bancario, la crescita del terziario a Roma fu sostenuta da ingenti finanziamenti ed investimenti in infrastrutture e nei trasporti.
Con l'avvento di internet e lo sviluppo dell'hi-tech, nel terzo millennio esploderà il «terziario avanzato», seguirà quindi la nascita d'attività sempre più sofisticate. In ogni modo il terziario ancora oggi è la colonna portante dell'economia romana.
Lo scenario sociale della roma di fine ottocento
Torniamo agli albori d'inizio Novecento e al trentennio successivo. In quell'epoca dopo lo spostamento dell’intera macchina della gestione amministrativa del Governo centrale aumentò il numero dei residenti, di conseguenza si fece pressante l’esigenza di nuove abitazioni. Fino ad allora a Roma esisteva una società rigidamente gerarchica suddivisa in "clero" e "nobiltà" che era l'élite governante, seguiva una ristretta alta borghesia nota anche come "generone", composta da ricchi mercanti, banchieri e proprietari terrieri, che si distinguevano per il loro potere economico ed agiatezza rispetto alle classi più basse. Quest'élite sociale spesso cercava d'emulare lo sfarzo e il prestigio della nobiltà, anche contraendo matrimoni strategici col fine d'accrescere il proprio status. A seguire, nella scala sociale romana c'era il "proletariato urbano" cioè la vasta maggioranza del popolo, comprendente la classe operaia, i lavoratori giornalieri, i piccoli artigiani e la manodopera non qualificata: gente semplice che viveva in condizioni d'estrema povertà affrontando precarietà lavorativa e condizioni di vita difficili, abitando in "sacche popolari" anche comprese dentro certi rioni e zone centrali e fuori le mura aureliane, in case dove le condizioni igieniche erano scarse.
principio e crescita del commercio romano nel novecento
Sino alla "breccia di Porta Pia" il clero occupava a Roma una posizione di potere assoluto, gestendo sia quello temporale quanto quello spirituale, mentre la nobiltà romana e l'alta borghesia mantenevano monopolio, privilegi e influenza economica. Divenuta italiana e col nuovo prestigioso ruolo di capitale del Regno, nella città eterna comparve una nuova classe sociale: il «ceto medio».
Si trattava d'una tipologia di persone appartenenti a una categoria che con dignità si collocò a metà tra l'opulenza e le privazioni.
Fu un oceano di gente, che si trasferì nella capitale per motivi professionali da ogni parte d'Italia e del mondo. Un'impressionante moltitudine di persone composta prevalentemente da funzionari amministrativi, impiegati con ruoli dirigenziali, diplomatici rappresentanti delle proprie nazioni nelle tante amabasciate e consolati, intellettuali, giornalisti, politici, impiegati, professionisti di vario genere, eccetera. E fu così che la popolazione residente della città eterna, nel nuovo ruolo di capitale d'Italia aumentò vorticosamente di numero. Tutti questi "romani acquisiti" (i medio-borghesi) avevano un reddito intermedio o medioalto e soprattutto necessitavano di una casa da abitare. Ci fu di conseguenza un vero e proprio boom economico-sociale caratterizzato da una rapida espansione della città, e soprattutto delle attività di scambio di prodotti e di servizi. Una nuova realtà, un affollato e selvaggio "porto di mare" che richiese l'immediato ausilio d'una regolamentazione commerciale. Fu così che vennero istituite le "autorizzazioni amministrative" ossia le "licenze" rilasciate esclusivamente dal Comune di Roma per autorizzare il proseguo o la nuova apertura delle attività. In particolar modo quelle dei negozi e dei mezzi di trasporto pubblico.
Roma divenne "terra di conquista" degli investitori di tutto il pianeta e polo d'attrazione per il commercio, per lo shopping ed anche per la spesa di generi di prima necessità. In gran parte delle piazze e delle vie centrali in particolar modo piazza di Spagna, via del Corso e via dei Condotti esplose il via vai della bella gente. Tutto il nucleo della città eterna in pochi decenni divenne una destinazione di prim’ordine, soprattutto per gli amanti del "bel vestire", un immenso tempio della moda e del glamour delle grandi firme internazionali, che almeno fino al 1930, s'intrecciarono con l’autenticità dei mercati tradizionali e la maestria dell’artigianato locale. Roma, col suo mix di storia, antichità, arte, bellezza, salotti mondani e letterari, divenne un’esperienza indimenticabile per ogni visitatore.
i magnifici negozi e salotti romani del novecento
Una città in cui si respirava storia, arte e stile. Un luogo magico in cui la ricerca del bello e l’eleganza sembravano elementi innati, quando al Tritone c'erano i «Fratelli Serrini» ed Armando da gran signore serviva la sua clientela sempre in maniche di camicia di seta. Eppoi al Corso c'era quell'altro gran signore del pettine e dell'acconciatura «Eusebio De Luca», sempre compito e gentile tra un sorriso e una battuta, era il parrucchiere delle principesse, delle contesse romane e delle donne benestanti in genere e ci teneva a far sapere a tutti che era nato in Abruzzo una terra illustre d'artigiani. Il buon Eusebio nelle sue eleganti e femminee movenze e con voce aggraziata, tra una chiacchierata e l'altra creava stile col pollice della sua mano sinistra mentre manteneva il dito medio fermo per per un taglio preciso. Era un maestro del pettegolezzo di salotto, e si muoveva leggiadramente tra le blasonate clienti stimolando abilmente un'accesa partecipazione al dialogo d'alto rango. E le sue ricche clienti, così pungolate, tra tagli e voluminose acconciature, non disdegnavano di ciarlare a proposito di tutto: pettegolezzi, prime di teatro, cronache recenti sui quotidiani, fulgidi ritagli di storia e arte, di armi e d'amori. Spesso si ricordava e si "sparlava" di Gabriele D'Annunzio reporter di caccia alla volpe alla Pineta Sacchetti ancor prima delle sue esperienze di "estetismo" nonché di scrittore, poeta, autore teatrale, militare, politico, giornalista e scrittore. Si chiacchierava della terribile peritonite che si portò via a New York "il Latin Lover" (Rodolfo Valentino). Si blaterava con invidia della meravigliosa Greta Garbo cercando di trovarle e ingigantire improbabili difetti. Ebbene con l'esimio Eusebio si poteva ben dire che a Roma gli abruzzesi non furono in quell'epoca soltanto zampognari.
E poi c'era il «Palazzo Bocconi» al Corso all'altezza di largo Chigi nei pressi di piazza Colonna a pochi passi da Montecitorio. I fratelli
Ferdinando e Luigi Bocconi, commercianti milanesi, acquistarono a fine Ottocento per novecentomila lire un terreno per creare un grande edificio commerciale sul modello dei magazzini parigini, con la prestigiosa idea del grande emporio multigenere «Alle Città d'Italia». Quel palazzo eclettico diventò nel 1917 il Palazzo della Rinascente.
Quel periodo verrà chiamato con nostalgia "Belle Époque romana"
per ricordare un'epoca percepita come felice e spensierata, segnata da un grande ottimismo verso il progresso (da chi poteva permetterselo). In contrasto con le catastrofi che presto seguiranno. L'aria che si respirava era caratterizzata dalla fiducia per lo sviluppo economico, scientifico e tecnologico, dalla fioritura culturale e dalla propensione al divertimento. In piazza di Spagna, piazza del Popolo, piazza Colonna, Campo Marzio, Trevi, Colonna, pullulava il mondo, tra i tanti negozi famosissimi, purtroppo dolorosamente scomparsi, s'incrociavano uomini e donne elegantemente vestiti alla moda dell'epoca. Giravano a piedi e in carrozza turisti da ogni dove tra cui famosi intellettuali e artisti. Molti eminenti personaggi "forestieri" facevano parte del
«Grand Tour»,
un lungo viaggio culturale intrapreso dall'aristocrazia europea e non solo, destinato a
"perfezionare il proprio sapere", il quale aveva una durata non definita e che di solito aveva come destinazione chiave l'Italia ed in particolare la città eterna.
Nell'affascinante percorso di compere nel centro della capitale, si vide una transizione significativa soprattutto della moda, con la liberazione del corpo femminile dal corsetto e l'emergere di stili più fluidi e ispirati a correnti artistiche come l'Art Nouveau. Fu in questo periodo che fece la sua prima comparsa il tailleur. E poi s'affermò la cosiddetta “manica a prosciutto”
sempre molto stretta sull’avambraccio, con un volume che si ampliava dal gomito alla pala, dove era talmente increspata da superare la linea delle spalle. Le gonne persero ogni accenno di rotondità sui fianchi grazie all’abbandono delle vecchie sottostrutture armate, di cui erano state regine la
crinolina
e la
tournure, lasciando spazio alle sottogonne in tessuto, che diedero volume principalmente all’orlo della gonna, introducendo la cosìdetta
“linea ad A”
ossia una silhouette aderente in alto che si allarga gradualmente verso il basso, formando una forma simile alla lettera "A", un taglio versatile in grado di dar pregio all'armonia del corpo femminile, attribuendo attrattività a non poche corporature, valorizzandone il punto vita, e nascondendo discretamente fianchi e cosce in modo armonioso. Anche per quanto riguardava gli uomini cominciarono a vedersi i primi cambiamenti. Alla
marsina e alla
redingote
s'andò sostituendo una giacca più corta, che arrivava fino al fianco e con il davanti arrotondato. I pantaloni diventarono più larghi e pratici rispetto al periodo precedente. I cappelli più in auge rimasero il
cilindro e la bombetta. A differenza dell’abbigliamento femminile, nell’abbigliamento maschile vennero usati soprattutto colori scuri con l’obbligo del nero per le occasioni serali, in contrasto con il bianco delle camicie, all'epoca caratterizzate dallo
"sparato" nella parte frontale dell’abbottonatura, e dal colletto alla coreana o con piccole punte ripiegate sul davanti in modo da non coprire l'adorno della cravatta o dell’ascot. Anche le scarpe erano principalmente di colore nero, rischiarate dalle ghette, in alternativa alle quali si indossavano gli stivaletti abbottonati sulla parte esterna del dorso del piede. Infine, come in tutto il mondo occidentale di quella romantica epoca, anche l’abbigliamento del gentiluomo della
"bella epoca romana"
era completato da bastone e guanti scuri.
I cambiamenti furono inizialmente promossi dall'alta moda e dalle élite, che influenzarono le tendenze e ispirarono i sarti, anticipando le trasformazioni che avrebbero raggiunto un pubblico più ampio attraverso le magnifiche esposizioni nelle vetrine dei negozi. Naturalmente Roma, quella Roma, non resistette al fascino di quei cambiamenti epocali della moda. Le giovani donne (ma anche non pochi ragazzi) iniziarono a emigrare dalle zone rurali, soprattutto dal sud Italia, anche verso la capitale dove le sartorie offrivano nuove opportunità di lavoro. Molti di loro impararono l'arte con enorme passione e dedizione dimostrarono un'immensa predisposizione alla creatività. Fu da allora che quello di sarta/o divenne uno dei mestieri più ambiti e prestigiosi. Perchè a Roma l'esigenza del bello aumentava sempre più, esattamente come aumentava il ceto medio.
Nacquero le prime sale cinematografiche, venne la
"Sala Iride" al Corso aperta da Giuseppe Cocanari. E poi il
"'Lux et Umbra' "
a piazza San Lorenzo in Lucina che fu uno dei più importanti cinematografi della capitale. Poi venne la sala
"Cinematografo Artistico Italiano" in via Celsa. Poi da allora, nei decenni immediatamente successivi ne aprirono tante altre, che divennero prestigiose e famose, oggi scomparse. Era l'epoca del film muto, arrivarono stars che fecero sognare gli spettatori romani, come Harold Lloyd, Mabel Normand, Rodolfo Valentino, Mary Pickford, Charlie Chaplin. Nella seconda metà degli anni Venti apparì anche sugli sugli schermi capitolini la divina attrice svedese Greta Garbo, l'algido angelo che fece innamorare milioni di uomini.
Le sale da tè romane d'inizio secolo, in particolare quelle di stile inglese erano un'alternativa di lusso ai non pochi prestigiosi caffé e contribuirono a diffondere la tradizione
dell'afternoon tea romano
diventando anch'esse punti di ritrovo per intellettuali, artisti e personaggi di spicco. E poi c'erano le violette di zucchero della «Pasticceria Ungherese» vicino a piazza Colonna.
A via Condotti si radunò l'élite dei migliori negozi di Roma, salotti che non tutti i romani in quell'epoca potevano permettersi .
"Vacanze romane" una canzone dei Matia Bazar che partecipò al trentatreesimo festival di Sanremo classificatasi al quarto posto, interpretata dalla sublime voce di Antonella Ruggiero, richiama con nostalgia i tempi passati di una Roma scomparsa, senza riferimenti ad un periodo in particolare, ma che riporta nelle atmosfere alle romantiche epoche in cui il centro della città eterna era uno splendido salotto mondano, culturale e di "profumate vacanze romane".
A piazza di Spagna, via dei Prefetti e a Santa Maria in Aquiro gli empori di "Zabban", "Tebro" e "Capparoni" proprietari e commesse/i consigliavano le loro stoffe toscane, lombarde, di Parigi e le lane di Biella e Berlino, ed i primi cachemire d'oriente. Sempre al Corso c'era il negozio di moda maschile "Ousset". Dirimpetto la "Pellicceria Alfredo Pavia". In via Capo Le Case l'atelier "Forneris". In via del Tritone la grande esposizione de "I grandi magazzini Cohen" ove tra voragini di stoffe e biancheria vi lavoravano nel retro sarti e sartine ed apparivano i primi vestiti su misura. Le cappellerie del centro, tra cui "Troncarelli" in via della Cuccagna nei pressi di piazza Navona, "Radiconcini" al Corso, "Giovinazzi" all'Argentina, esponevano in vetrina i loro bellissimi modelli di cappelli, guanti e bastoni da passeggio. A Testaccio, nel 1919 Alberto "Trancanelli" aprì il suo rinomato negozio di calzature per uomo, donna e bambini. Potrei fare un elenco smisurato di negozi che hanno fatto la storia e la magnificienza del centro di Roma e dei nuovi quartieri umbertini. Attività che oggi sono solo un nostalgico ricordo dei tempi che furono. Fu in quel periodo romantico che nacque anche tra i benestanti residenti a Roma un forte e preoccupante nazionalismo.
Il rovescio della medaglia
Ma c'era "l'altra faccia del pianeta". Anche nella giovane nazione sopraggiunsero enormi cambiamenti sociali, con la crescita del movimento operaio e con la nascita delle prime forme di stato sociale. Così anche a Roma il confronto tra lo stile di vita delle classi più in difficoltà con quello della "media borghesia" mise in evidenza un'enorme disparità. Le forti disuguaglianze stigmatizzarono la mancanza di benessere in cui riversava il proletariato romano. Fu allora che nacquero le famose massime «vorrei ma nun posso», «i poveri s'ammazzano e li signori s'abbracciano», «le mani sò troppo corte pé raggiunge la luna», eccetera eccetera. Prima d'allora, nello Stato Pontificio c'era un baratro che separava i ricchi e i poveri, c'era l'impossibilità che anestetizzava i bisogni e i desideri, c'era una "ovvia" rassegnazione. Nei primi decenni del Novecento la protesta e la rabbia dei lavoratori mal retribuiti e con pochi diritti si manifestò con i primi scioperi e manifestazioni. Nacquero le prime camere del lavoro per tutelarli. Una marea di italiani, anche romani, decisero d'emigrare altrove nel mondo in cerca di fortuna. Probabilmente anche queste discrasie sociali, collegate alla follia di certi personaggi che saliranno al potere nella prima metà del secolo, contribuiranno all'avvento degli orrori che si susseguiranno nel corso degli anni successivi.