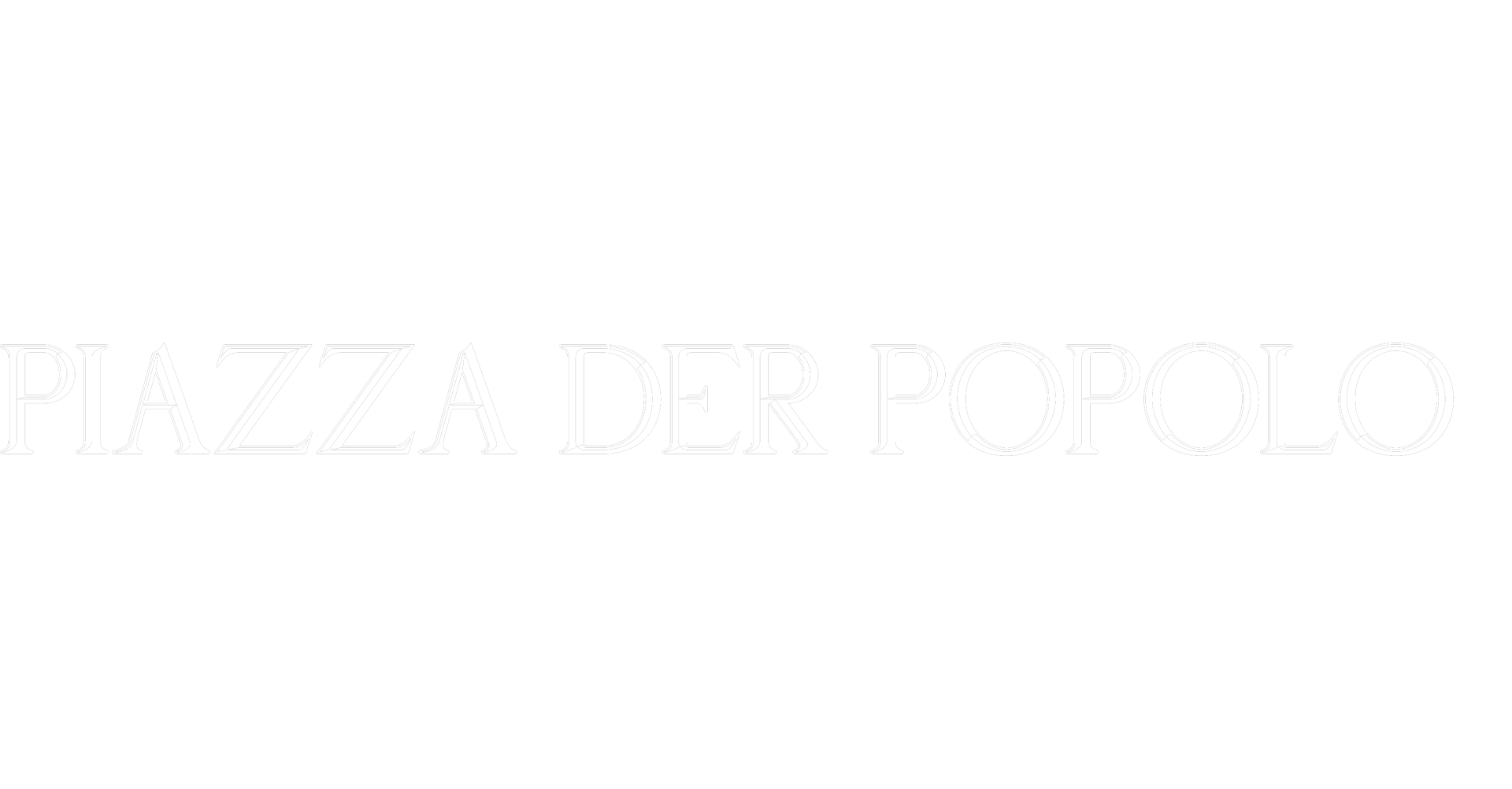OCCUPAZIONE, RESISTENZA, LIBERAZIONE di Claudio Di Giampasquale
Il 4 giugno del 1944 Roma venne liberata dai nazisti dopo un’occupazione che durò nove mesi. La popolazione romana affrontò privazioni, violenze e sofferenze, in bilico tra l’insurrezione armata e la resistenza passiva. Le avanguardie tedesche investirono Roma, contrastate in vari punti della cintura urbana e a ridosso del centro, dalla reazione spontanea e non coordinata di singoli reparti militari e di civili in armi che, assieme, opposero resistenza all'urto organizzato e concertato delle truppe germaniche. I combattimenti e i blitz lasciarono sul campo in tutti i rioni e quartieri di Roma, 1287 caduti tra cui decine di donne. Nei feroci scontri che avvennero a Porta San Paolo e alla Montagnola fu uccisa la ventinovenne Suor Teresina D'Angelo impegnata come infermiera in prima linea.

La vera opposizione agli invasori, in senso istituzionale ossia intesa non solo come mobilitazione dei cittadini ai tedeschi, ma come organizzazione politico-militare, nacque giovedi 9 settembre 1943 in via Carlo Poma nel quartiere Prati, quando, in segreto, alle ore 16:30, Alcide De Gasperi, Pietro Nenni, Giorgio Amendola, Ugo La Malfa, Meuccio Ruini, Alessandro Casati ed altri, costituirono il Comitato di Liberazione Nazionale che si poneva l'obiettivo, oltre che di combattere, sopra a tutto di colmare provvisoriamente il vuoto più assoluto d'ogni «autorità costituita». A questo comitato romano definito per brevità CLN in seguito fu inserito l'aggettivo "centrale" per distinguerlo dal CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) che venne costituito a Milano nel successivo mese di febbraio.

Facciamo un passo indietro di pochi mesi: l'armistizio del settembre 1943 e la conseguente brutale reazione dell'esercito tedesco provocarono una catastrofe nella struttura politica, amministrativa, civile e militare italiana. In pochissimi giorni la Wehrmacht occupò gran parte della penisola, diede la caccia, disarmò e catturò gran parte dei soldati del Regio Esercito.
La sera dell'8 settembre le forze tedesche attaccarono Roma. Il giorno seguente, mentre nella città infuriavano gli scontri tra la Wehrmacht e il Regio Esercito, il re Vittorio Emanuele III e il capo del governo, il maresciallo Pietro Badoglio, abbandonarono in tutta fretta la capitale e ripararono a Brindisi.
Sabato mattina 11 settembre 1943, dopo tre giorni di feroci combattimenti, Roma capitolò. Nonostante dubbie promesse al generale Carlo Calvi di Bergolo di considerare
Roma città aperta, il feldmaresciallo Kesselring prese rapidamente misure draconiane per assicurare il controllo tedesco della capitale; con l'ordinanza affissa sui muri della città la sera dello stesso sabato, il comandante tedesco dichiarava che la città era
"territorio di guerra" sottoposta alle leggi tedesche di guerra, che
"ogni sciopero era proibito", che eventuali resistenti sarebbero stati "giudicati e fucilati con giudizio sommario"; il feldmaresciallo affermava che egli era
"deciso ad assicurare la calma e la disciplina".
La popolazione era alle strette: la pasta e la farina costavano 180 lire, la carne 230, il burro 600 lire, l'olio 1700. Prezzi incredibili se si pensa che allora, uno stipendio medio non superava le 1500 lire ed erano pochissimi quelli che ne avevano uno.

Le prime attività della Resistenza romana e di numerosi agenti segreti intralciarono il controllo nazista della capitale, ma le speranze di una rapida liberazione con l'arrivo degli Alleati erano sempre più ardue. Il 6 ottobre 1943 venne ordinato il disarmo di tutti i carabinieri in servizio nella capitale (circa quattromila uomini). Il giorno dopo, una cifra stimata tra i millecinquecento e i duemilacinquecento militari dell'Arma furono deportati in Germania, la rimanente parte si diede alla macchia, molti di loro confluirono nelle file del Fronte Militare Clandestino dei Carabinieri organizzato dal generale Filippo Caruso.

Nelle prime ore dell'alba di sabato 16 ottobre 1943 le truppe armate naziste irruppero improvvisamente nel Ghetto di fronte all'isola Tiberina e avvenne la grande operazione di rastrellamento e deportazione degli ebrei romani senza che il papa Pio XII e le autorità vaticane, ancora concentrate su una politica di equidistanza e di ricerca di un accordo tra angloamericani e tedeschi in funzione anticomunista, potessero intervenire con qualche risultato concreto. La popolazione romana affrontò con valore senza rassegnazione le privazioni, le violenze e le sofferenze, in bilico tra l’insurrezione armata e la resistenza passiva. C'era paura e rabbia, c'era disperazione ovunque. C'era coraggio.
Nel frattempo le truppe alleate avanzavano verso nord alla volta della città eterna, cercando di sfondare le linee fortificate difensive tedesche che agli ordini del generale Kesserling avevano creato uno sbarramento di fuoco per bloccare l’accesso alla via Casilina e tutti i principali collegamenti con Roma. Gli alleati attaccarono in forze lungo tutte le direttrici e riuscirono a sfondarle, spingendo la Wermacht ad attestarsi più a nord, lungo la Linea Gustav, imperniate sulla posizione strategica di Cassino.
Il 22 gennaio 1944, per superare la logorante situazione di stallo sulla
Linea che demarcava gli schieramenti bellici, le forze alleate effettuarono uno sbarco ad Anzio incontrando inizialmente una resistenza debole. Nelle prime ore dopo lo sbarco sembrò che la strada fosse aperta per un'avanzata rapida verso Roma. La notizia si sparse velocemente ed arrivò subito nella capitale. Si diffuse l'euforia e l'attesa di un'imminente liberazione. In realtà, in breve tempo la situazione cambiò completamente, i nazisti si riorganizzarono e colpirono duramente le forze alleate che il 15 febbraio dopo una meticolosa organizzazione strategica, bombardarono l'Abbazia di Montecassino ove era dislocato il punto focale della difesa nazista. L'effetto sull'edificio fu drammatico: un tenente tedesco riferì che fu come se
«... la montagna si fosse disintegrata, scossa da una mano gigantesca».

Intanto i gruppi di Resistenza romana cercavano in tutti i modi, disperatamente, di agevolare l'avanzata delle truppe di liberazione verso nord. Mancavano solo 62 chilometri per raggiungere l'Urbe, i più difficili. Anche in assenza di un ordine di insurrezione generale, i partigiani attaccarono i reparti tedeschi nella città e nei piccoli centri intorno, al fine di catturarne uomini o mezzi e di evitare la distruzione di infrastrutture locali nel corso di operazioni di retroguardia volte a rallentare l'inseguimento degli Alleati che lentamente si avvicinavano, faticosamente. Ma avanzavano inesorabilmente. I nazisti e i collaborazionisti fascisti si ritiravano verso est e nord-est lungo diverse strade, tra cui la Cassia e la Flaminia. Nel fronte sud orientale della città lungo la via Appia, i carabinieri di Filippo Caruso e i partigiani combatterono eroicamente contro i reparti tedeschi. A Villa Certosa sulla Casilina, sei di loro persero la vita.
Le squadre Matteotti attaccarono i tedeschi, e ci fu un violento scontro alla stazione Ostiense. I partigiani della Banda Roma di Prima Porta al comando del capitano Raffaele Ridolfi, si battono contro una colonna germanica composta da sei camion, tre autovetture e due carri armati. Uno dei carri armati nazisti venne bloccato dal giovane Felice Rosi, 19 anni, che riuscì a piazzare due bombe a mano nei cingoli. Il povero Felice però perse la vita colpito in pieno da una raffica di proiettili, mentre tentava di bloccare anche l’altro carro. Gli scontri furono cruenti anche a San Basilio, Tiburtino-Terzo e Pietralata.

Combattendo sulla via Salaria, cadde ucciso Ugo Forno detto “Ughetto” un coraggioso ragazzino di tredici anni che con i suoi compagni riuscì ad evitare che i tedeschi potessere far saltare il ponte sull’Aniene. In quell'azione di difesa morì in ospedale anche Francesco Guidi e restò mutilato di un braccio Sandro Fornarino. A Monterotondo, ragazzi della Resistenza romana guidati da Alvaro Marchini combatterono stoicamente catturando circa duecentocinquanta nazisti.
Tra i numerosi episodi cruenti avvenuti nella città e nei dintorni, spicca l'Eccidio de La Storta che avvenne quando i nazisti che gestivano la prigione di via Tasso decisero di fuggire verso nord, caricando in fretta e furia una quindicina di persone: perseguitati politici e partigiani che erano nelle loro mani. Il viaggio dei prigionieri non durò a lungo, a pochi chilometri dalla capitale, raggiunta la frazione di La Storta, i detenuti furono fatti scendere dal camion, spinti con la forza delle armi puntate in un boschetto al km 14.200 della via Cassia e trucidati barbaramente. Tra quei poveretti c'erano Bruno Buozzi e Edmondo Di Pillo.

Domenica 4 e lunedi 5 giugno 1944, le truppe americane del generale Mark Wayne Clark riuscirono a superare nei pressi di Valmontone le ultime linee difensive dei nazisti ed entrarono a Roma dalle vie consolari Casilina e Appia, ricevendo l'entusiastica accoglienza della popolazione. Al loro passaggio migliaia e migliaia di romani felici agitavano bandiere impazziti d'entusiasmo.
Martedi 6 giugno la notizia dello sbarco in Normandia. È finalmente il secondo fronte, che porterà al tracollo della Germania