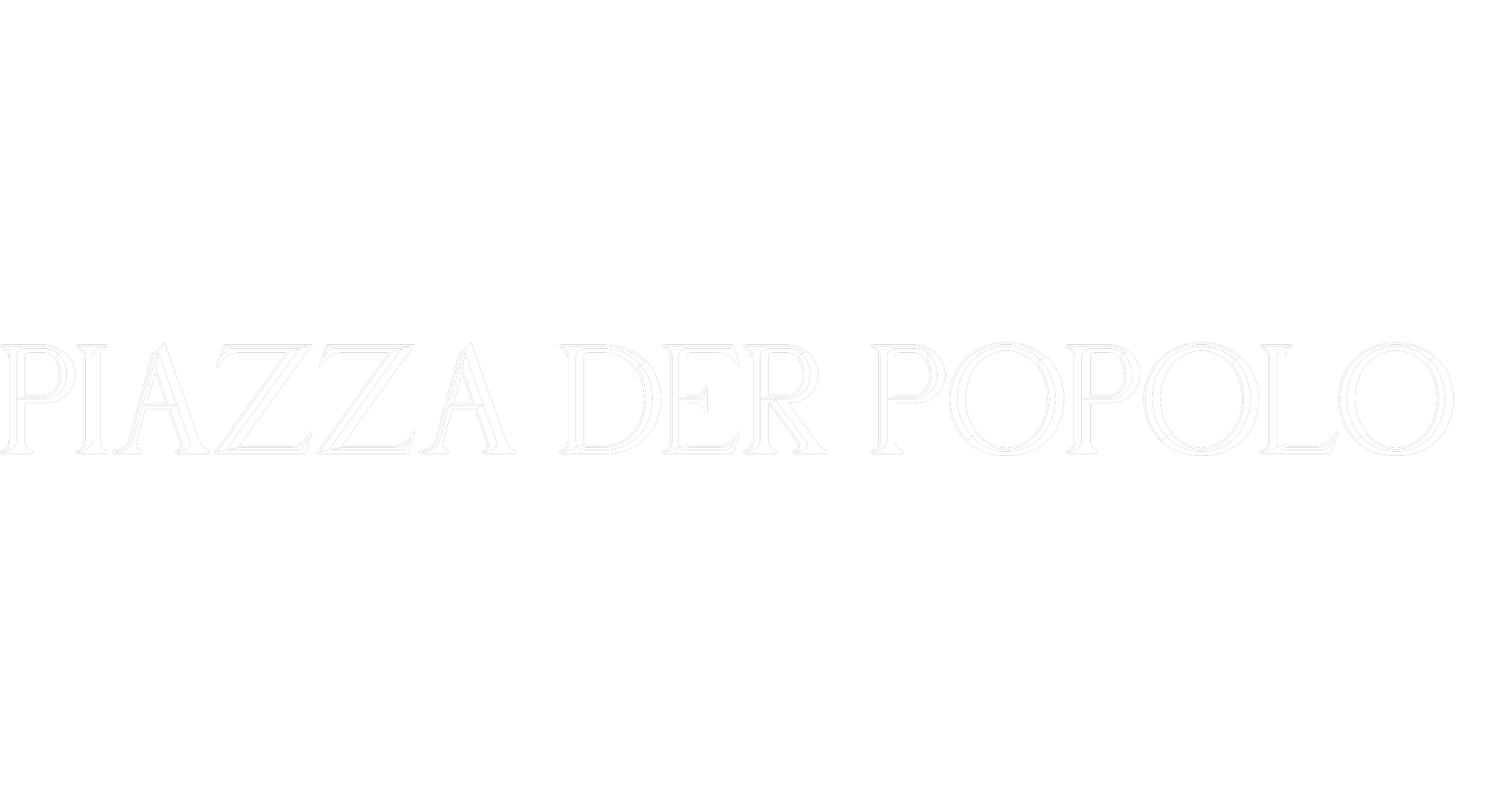MESCITA DEL VINO: LE MISURE ROMANE di Claudio Di Giampasquale

Con la fine dell’antica civiltà romana, a tramandare la tradizione enologica tanto cara al popolo dei cesari ci pensarono prima i monaci e poi il susseguirsi dei papi il cui interesse per il settore era dettato dalle cospicue entrate assicurate dalle tasse sul vino. Le normative papali erano numerose e gli osti dovevano attenersi scrupolosamente ad esse. Queste regole avevano lo scopo di moderare il consumo eccessivo di vino da parte dei romani, che spesso, dopo abbondanti festeggiamenti, si lasciavano andare a risse violente. Inoltre, si cercava di prevenire le frodi degli osti, una delle più ricorrenti era la
"sfogliettatura", ovvero il servire il vino in boccali non completamente pieni. I recipienti dell'epoca, erano di terracotta o metallo e quindi non permettevano di vedere il contenuto.
Alla fine del sedicesimo secolo Sisto V per porre rimedio a tale malaffare decise di rendere obbligatorio nelle osterie l’utilizzo di oggetti trasparenti di vetro, con una nuova legge che imponeva di mettere bene in mostra la quantità di vino presente all'interno dei contenitori con cui veniva servito. Venne quindi indetto un bando a cui parteciparono i migliori artigiani vetrai dello Stato della Chiesa e degli stati confinanti. Al pontefice piacque molto l'idea di un mastro vetraio veneziano di religione ebraica un certo Meir Maggino di Gabriele che inventò un sistema di misurazione della mescita che prevedeva sei determinazioni della grandezza dei contenitori in vetro, una misura che definì col termine "foglietta" di seguito romanizzato in "fojetta" (in quanto contrastava e risolveva il reato della "sfogliettatura") nonchè una caratteristica forma degli stessi contenitori trasparenti che tanto piacque al pontefice: una particolare silhouette della bottiglia con base larga che saliva a ristringersi decisamente verso il collo per poi allargarsi a mo' di campana di una tromba per favorire la fuoriuscita del vino e poterlo versare comodamente nel bicchiere, nella caraffa o nel calice. Inoltre vi doveva essere stampigliata sul corpo l'unità di misura corrispondente al contenuto. Meir Maggino di Gabriele si aggiudicò la gara per quindici anni e nel mese di luglio del 1588 entrò in vigore la legge che obbligava tutte le osterie a utilizzare i contenitori di vetro prodotti dall'artigiano veneziano che per mantenere e godere di tale privilegio venne costretto a sborsare una tassa annuale di cinquecento scudi. Fu un provvedimento intelligente e favorevole in quanto accontentava tutti, ai romani piacque molto il nuovo modo di veder servito il vino nelle osterie molto più onesto e trasparente e quindi il numero degli avventori delle locande crebbe sin da subito, la conseguenza fu la maggior soddisfazione degli osti che videro salire non poco i propri profitti. Il maggior incremento del giro d'affari favorì un aumento dei proventi da tassazione quindi salirono le entrate per lo Stato della Chiesa. Naturalmente il più contento di tutti fu il buon Meir Maggino di Gabriele che in tre lustri produsse una quantità enorme di contenitori con notevoli guadagni per la sua bottega.
Col tempo questo sistema di mescita divenne un vero e proprio simbolo della romanità. Più dei bar di oggi le osteria in passato rappresentarono il punto focale e di riferimento sociale, nei rioni erano una marea ove si parlava, si discuteva, si giocava e ci si corteggiava. Nelle osterie si raccontavano le disgrazie, la fatica, le delusioni d’amore e molto spesso si trasformavano anche in luoghi di pesanti sfottò e risse. Sulla tavola il contenitore di vetro da 2 Litri dalla fine del diciannovesimo secolo venne definito «er barzillai» dal nome di un politico romano dell'epoca che usava offrire vino in gran quantità ai suoi elettori. Quelle da 1 litro vennero definite «tubbo». Quelle da mezzo litro «fojetta». Quelle da un quarto di litro «quartino o
mezza fojetta». Quella da 1/5 di litro «chirichetto» e quella da 1/10 di litro «sospiro o
sottovoce» così chiamato probabilmente perchè nell'ordinarlo ci si vergognava di non aver abbastanza denaro per bere di più.
Ormai oggi è di moda la "carta dei vini", nei rioni e nei quartieri di Roma i ristoranti anche se si definiscono osterie o trattorie, difficilmente servono il vino alla mescita. Ce ne sono ma non molti, certamente molti meno di una volta, per cui le caratteristiche "fojette" non sono conosciute dai più giovani. Tuttavia basta recarsi nelle mitiche «fraschette» dei Castelli Romani per rivederle sulla tavola, lì la mescita col suo caratteristico sistema dei contenitori in vetro è il cavallo di battaglia insieme alla "porchetta", alle "coppiette" e ai prelibati salumi e formaggi del luogo nonché altre specialità romanesche. Quella dei Castelli Romani è da secoli una zona ideale per la coltivazione della vite, sia per la composizione dei terreni sia per la mitezza del clima. Il principe Marcantonio Colonna concesse alla città di Frascati uno Statuto che regolava la viticoltura, le modalità della vendemmia, la lavorazione e la vendita dei vini locali. Proprio in quegli anni nacquero le «fraschette» così dette perchè esponevano come simbolo frasche e tralci di vite.
«Oste, portace 'n artro litro»
si canta ancora oggi sulle note de
«La società dei magnaccioni» un vecchissimo pezzo a metà strada tra una canzone romanesca e uno stornello, di origini sconosciute che ricorre alla semplificazione e all'uso di termini molto colloquiali, canta il piacere di bere il vino a Roma. Eccone una magnifica versione interpretata dall'indimenticabile Gabriella Ferri.