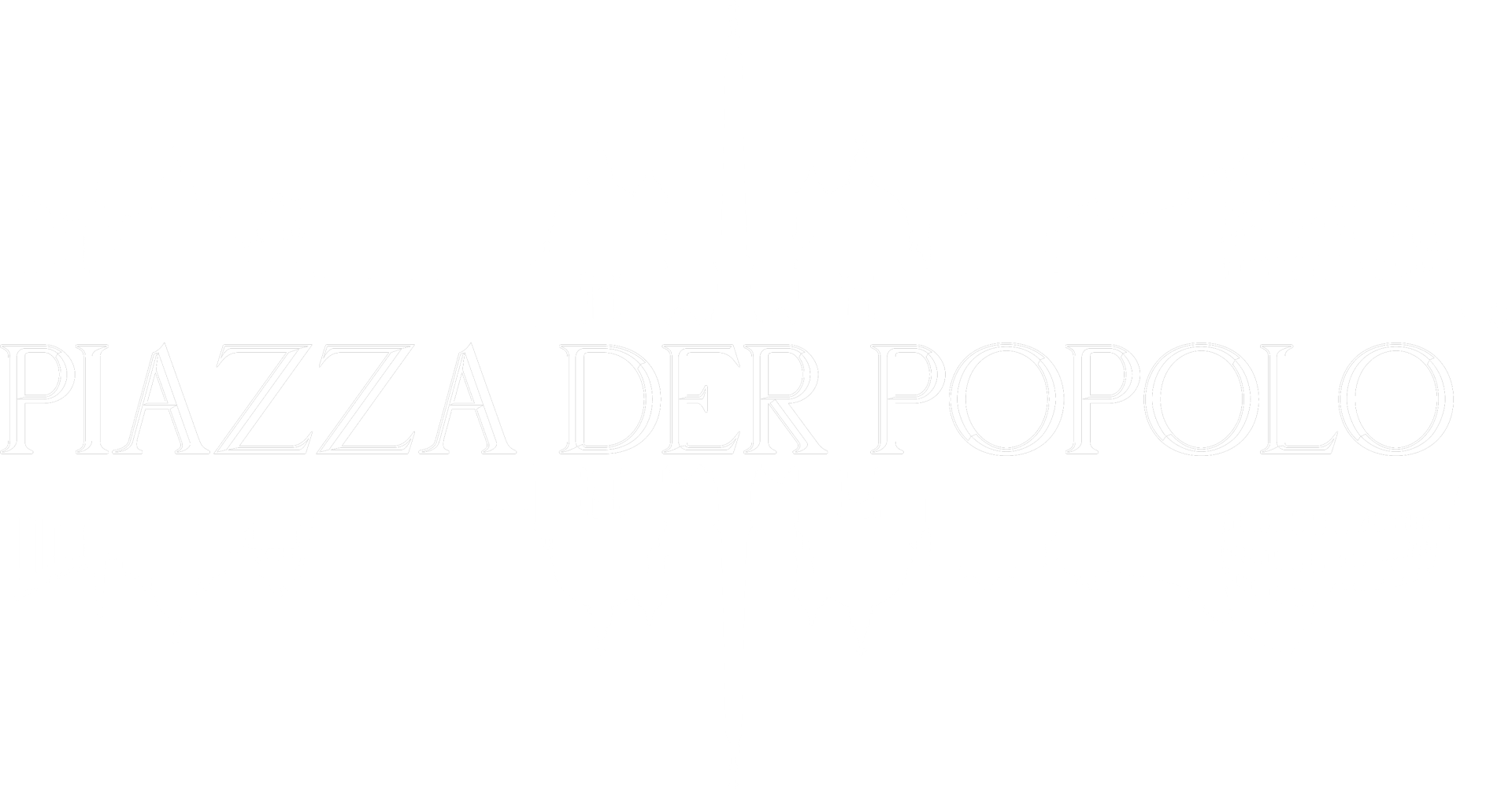NUN C'È TRIPPA PÉ GATTI di Claudio Di Giampasquale
Nel medioevo, seppur apprezzati come cacciatori di topi, i gatti furono a lungo perseguitati, perché considerati manifestazione del diavolo e "idoli di tutte le streghe", come li definì nel quindicesimo secolo Papa Innocenzo VIII. Tuttavia per loro fortuna, nei successivi secoli le cose gradualmente cambiarono e i romani accettarono di buon grado la presenza dei gatti randagi. Ormai è da mezzo millennio che fanno parte della città, le colonie feline sono una realtà riconosciuta e tutelata. Basti considerare che Roma conta nel suo insieme circa quattromila colonie (censite dall'Asl) con quasi cinquantottomila felini (tra randagi e domestici).

Oggi a Roma il gatto randagio è un cittadino, e più o meno come un umano ha diritto di domicilio dove può e ha diritto di riunirsi. In ogni caso «è vietato sottoporlo a violenze»: tuttavia ciò, purtroppo, non riuscì ad accadere sempre neanche a Roma, città che li ama molto. Sfortunatamente per loro successe più volte in tempi bui di miseria e fame accaduti durante i secoli. Come avvenne durante il periodo delle la seconda guerra mondiale in cui ne vennero sacrificati non pochi per sopravvivere, purtroppo si sa che durante i conflitti bellici molte delle regole sociali decadono temporaneamente, e così anche sulle rive del Tevere, sotto la spinta della indigenza e della fame molti abitanti per sfamarsi e dar da mangiare ai propri figli sacrificarono diversi mici. Probabilmente se non l'avessero fatto forse molti di noi nemmeno sarebbero nati.
Con l'avvento del benessere, la pacifica convivenza tra gatti vagabondi e romani è tornata, certo con diritti sempre da difendere e riconquistare, ma con grande accoglienza e umanità. Non sono pochi coloro che contribuiscono a sfamarli e in caso di pericolo li salvano, li raccolgono, li accudiscono, li ricoverano e in certi casi li adottano, ebbene nonostante l'apparente indifferenza di una città frenetica troppo impegnata e spesso sconvolta dai ritmi moderni, in silenzio questi protettori condividono con i piccoli felini qualcosa di sovraumano e diventano i loro angeli. Qui a Roma vengono chiamati
«Gattari».
C'è un terreno sacro sul quale camminano i gatti randagi romani, un luogo che fu calpestato negli ultimi istanti di vita da un altro celebre romano: Giulio Cesare, è qui nell'area sacra nel mezzo di Largo Torre Argentina, che nell’anno quarantaquattro avanti Cristo fu pugnalato in seguito a una congiura ordita per farlo fuori. Sono passati venti secoli da allora, ma lo spirito del grande condottiero vive sicuramente in alcuni dei "gatti aristocratici" che frequentano e ormai dominano con orgoglio questi templi.
«Nun c'è trippa pé gatti » l'origine di questa espressione romanesca
La premessa sopra è per mettere in relazione i gatti randagi con Roma e i romani appunto con questo detto popolare. Quante volte abbiamo sentito o detto questa frase? Qui ai piedi dei sette colli molto spesso. Con questa espressione a Roma s'intende dire che
«non è possibile», o
«non c'è niente da fare», o
«non esistono alternative»
oppure
«non ce n'è per nessuno».

La sua storia non ha origine nell'antica e popolare urbe imperiale o papalina da dove arrivano la maggior parte delle «vox populi» romanesche, ma è stata pronunciata per la prima volta nel 1907 dal sindaco Ernesto Nathan trentott'anni dopo la proclamazione della città eterna a capitale d'Italia. Un aneddoto ormai famoso narra che la declamò severo quando appena insediatosi, nell'esaminare i bilanci comunali fortemente appesantiti e condizionati dalla gigantesca speculazione edilizia in corso, nel dare un'occhiata alle spese pubbliche e alle relative voci di costo, quando lesse la voce «frattaglie per gatti» e il congruo costo, chiese spiegazioni al funzionario di bilancio che gli aveva presentato il documento. Il dirigente amministrativo spiegò al neosindaco che il Comune di Roma sfamava diverse colonie feline nella città, delle quali ce n'era una, quella dei fori imperiali, che aveva il compito di proteggere archivio e documenti dai topi che infestavano il Campidoglio. Si evinceva inoltre dettagliatamente l'ammontare degli stipendi delle apposite figure preposte a nutrire i mici, dette «carnacciari» a dimostrazione di quanto questa mansione fosse importante e non un vezzo senza senso. Il sindaco Nathan, assai seccato, trovò invece questa funzione e relativo costo molto strampalata e inutile, decise quindi di annullarla annunciando che d'allora in poi i gatti avrebbero dovuto procurarsi da soli il cibo. E così tra le diverse voci di spesa modificate e annullate, prima di firmare il nuovo bilancio, scrisse sulla relativa riga: «Qui, non c’è trippa per gatti». Di conseguenza i poveri «carnacciari» di turno dovettero cercarsi un nuovo lavoro.