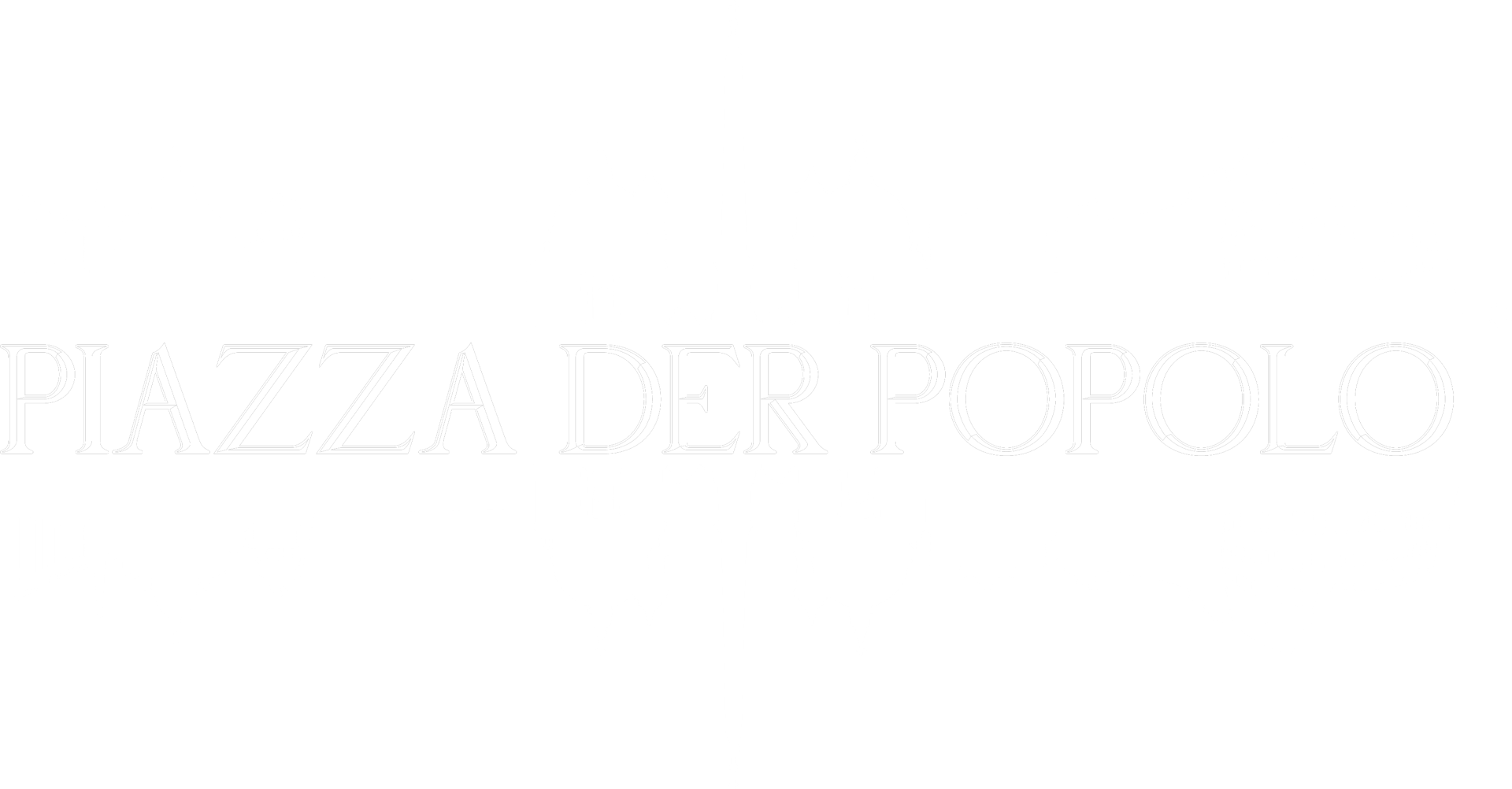L' OBELISCO AGONALE, CARDINE DI PIAZZA NAVONA di Claudio Di Giampasquale
Con una lunga storia di diciassette secoli questo monolite ha solennemente rappresentato "ad honorem" il baricentro di luoghi di culto e di memoria per poi evolvere nel ruolo di fulcro della magnificenza barocca e simbolica prosperità.
Il suo nome deriva dagli antichi «agoni» ossia le gara in onore di Giove Capitolino (Certamen Capitolino Iovi) che si tenevano nello «Stadio di Domiziano» (attuale piazza Navona, in quanto il nome dell'area gradualmente nei secoli mutò in "innagone" poi "navone" e quindi appunto navona) istituite dallo stesso imperatore per celebrare gli "agoni greci" ossia i «ludi circensi» che consistevano in pubbliche manifestazioni sportive dove gli atleti si sfidavano in diverse gare alle quali s'aggiungevano, corse di bighe e carri tirati da cavalli, competizioni musicali, e addirittura battaglie navali. Gli agoni che si tenevano allo Stadio Domiziano erano gare incruente riguardanti non solo lo sport ma anche diversi campi delle attività umane, dove il vincitore riceveva un premio per aver dimostrato, secondo la mentalità greca, le sue superiori doti fisiche e morali. L'ultimo imperatore della dinastia flavia sapeva bene che far divertire il popolo serviva ad ingraziarselo e a mantenere la calma sociale. Durante questi giochi e tornei venivano anche distribuite prebende e doni ai popolani più bisognosi. A presiederli era lo stesso Domiziano vestito di toga purpurea alla foggia greca, con il capo cinto da una corona d’oro e l’effigie del dio Giove.
Ma vediamo le origini e gli antefatti storici dell'obelisco agonale che oggi è l'imponente fulcro di quel meraviglioso gioiello barocco che è la «Fontana dei Quattro Fiumi» opera di Gian Lorenzo Bernini posta nel mezzo di una delle piazze più famose del mondo. Questo imponente monolite proviene dalle cave di granito di Assuan a sud dell'Egitto.
L'origine NELLa CAVa egiziana di granito rosa
L'antica cittadina egizia di Assuan situata nella punta più meridionale della terra dei faraoni, fu un crocevia di scambi commerciali e culturali ed ebbe una significativa importanza geografica come "portale d'accesso" dal e per il continente africano. Divenne particolarmente famosa per le sue cave di granito che gli egiziani impararono molto presto ad estrarre e trasportare lungo il corso del Nilo verso grandi distanze, per costruire tempi, obelischi e palazzi. La fama della bellezza dei colori rosa, rosso scuro, grigio e nero del granito di Assuan si espanse e raggiunse tutte le altre popolazioni del Mar Mediterraneo in particolar modo quelle dei fenici, cartaginesi, cretesi, greci e romani.
Una curiosità: nel giacimento a circa due chilometri a sud dal centro urbano di Assuan, a tutt'oggi si può contemplare l'imponente «obelisco incompiuto» un monolite gigante ancora disteso nel suo letto di granito rosa che non fu mai definitivamente estratto, con i suoi quarantadue metri se fosse stato issato e posto da qualche parte in posizione verticale sarebbe stato il più alto del mondo.
IL VIAGGIO VERSO ROMA E L'ARRIVO A CAMPO MARZIO
Nel primo secolo dopo Cristo, l'imperatore Domiziano rinomato per le sue manie di grandezza, con lo scopo di abbellire ulteriormente Roma devastata dal grande incendio di Nerone, fece prelevare dalle cave di Assuan un grande obelisco della lunghezza di diciassette metri con le quattro facciate prive di qualsiasi iscrizione. Il trasporto avvenne prima lungo il corso del Nilo verso la costa, poi via Mediterraneo ed infine verso la città eterna risalendo lentamente il Tevere. Tutto il tragitto sia fluviale che marittimo avvenne su due grandi navi da carico speciali a doppia poppa (cioè con la possibilità di manovra in entrambi i sensi in modo da evitare le inversioni di rotta) ciascuna con un contrappeso che la mantenesse a filo dell'acqua.
L'imperatore Diocleziano fece depositare l'obelisco al Campo Marzio per destinarlo all'abbellimento dell'area «Iseum Campense» dedicata alla dea Iside e al suo consorte Serapide. Prima di farlo issare su un basamento, lo fece decorare da scalpellini d'origine egizia che eseguirono sulle facciate geroglifici riguardanti alcune fasi della sua vita e de "l'Imperium sotto la sua autorità". Venne poi levigato mediante picchiettatura e sfregamento di ciottoli di diorite ed infine innalzato su un basamento.
LO SPOSTAMENTO AL TERZO MIGLIO DELLA REGINA VIARUM
Rimase a Campo Marzio per circa due secoli, sin quando l'autoproclamato imperatore Massenzio decise di spostarlo nel circo nei pressi della sua area privata al terzo miglio della «Regina Viarum» (via Appia) che comprendeva oltre al palazzo anche un circo e un edificio sacro che Massenzio trasformò in mausoleo commemorativo della memoria di suo figlio Valerio Romolo che aveva perso la vita poco più che adolescente probabilmente affogato nel Tevere, suo padre prostrato dal dolore dopo averlo seppellito nel monumento sepolcrale accanto al suo palazzo lo fece anche divinizzare sulla "Sacra vIa Summa" nel Foro Romano dedicandogli nientemeno che il «Tempio del Divo Romolo» ancora oggi visibile all'interno dei Fori Imperiali alle spalle del «Carcere Mamertino», tra il tempio di «Antonino e Faustina» e la basilica dello stesso Massenzio.
L'ABBANDONO DOPO LA CADUTA DELL'IMPERO
Ma torniamo al "monolite dioclezianèo" proveniente dalle cave di Assuan. Dopo la caduta dell'Impero, il Campo Marzio come gran parte del patrimonio urbano venne depredato dai barbari invasori e da sciacalli d'ogni dove. Nella città eterna ci fu un'improvvisa e disperata fuga generale per scampare a violenza e barbàrie. In breve tempo luoghi pubblici, palazzi, ville e case patrizie subirono oltre che saccheggi completi anche gravi danneggiamenti murari e distruzioni. Tutto fu spogliato e distrutto con una brutalità inaudita e in molti casi dato alle fiamme. Durante i tristi giorni del «Sacco di Roma» l'augusta Galla Placidia cadde in ostaggio dei Visigoti. Su ordine di Alarico re dei violenti guerrieri germanici furono risparmiati solo i luoghi di culto cristiani che vennero considerati come spazi di asilo inviolabili dove nessuno doveva essere ucciso.
Trascorsero secoli bui per la città Caput Mundi, in epoca altomedievale l'obelisco crollò spezzandosi e come tutte le rovine sparse nel residuo abitato ormai ridotto a pochi abitanti venne parzialmente sepolto dalla terra e ricoperto di arbusti riducendosi a vestigia del decadimento di una civiltà d'incommensurabile grandezza. Rimase giacente più o meno al centro delle rovine del circo di Massenzio, abbandonato per lunghissimo tempo, a mo' di silente gigante addormentato su un territorio che a lungo vide solo il passaggio di pastori, briganti e sporadici viandanti. Nessuno si adoperò al suo recupero.
IL RITORNO A CAMPO MARZIO NEGLI SFARZI DEL BAROCCO
Ma il tempo è galantuomo e secoli e secoli dopo, la città eterna, nonostante le innumerevoli sevizie e brutalità che la ridussero al buio, ritornò a splendere in tutta la sua luce e bellezza grazie al mecenatismo di non pochi nobili romani e di alcuni papi. Fu notevole il loro sostegno alla realizzazione di meraviglie architettoniche e attività artistiche e culturali e, più nello specifico, nei confronti degli stessi artisti coinvolti in tali attività. Tra la fine del sedicesimo secolo e i primi decenni del diciassettesimo, il nobile Giovanni Battista Pamphili, uomo di Chiesa, fu uno di loro.
Raggiunto il duecentotrentaseiesimo soglio pontificio, monsignor Pamphili assunse il nome di papa Innocenzio X quando venne eletto al conclave di giovedi15 settembre del bisestile anno 1644; fu consacrato il successivo 4 ottobre
Il suo amore per l'arte fu una fortuna per Roma che lo portò a farla diventare l’apogeo del Barocco. Naturalmente venne avvantaggiato oltre che dalla sua potenza politico-temporale anche e soprattutto dal destino. I suoi tempi videro la nascita di coloro che furono tra i più grandi artisti della storia dell'umanità. Tra i vari fenomeni a disposizione di scultori, pittori, scalpellini, muratori, eccetera eccetera nelle innumerevoli botteghe operose nello Stato Pontificio, fu complice la presenza nell’urbe di mostri sacri del calibro di Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini.
Papa Innocenzio X decise di "recuperare artisticamente" il «Campus Agonis» l'ampia porzione di Campo Marzio (frazionata tra proprietari privati ed enti ecclesiastici) che anticamente corrispondeva allo Stadio di Domiziano. Nacque così piazza Navona.
Il papa, che per la fortuna della città eterna, apparteneva a un casato perennemente in competizione con gli altrettanto blasonati Barberini e Farnese nella rivalità architettonica-artistica, volle che vi s'erigesse il palazzo intitolato ai Pamphilj nello stile barocco di cui era innamorato e che la piazza fosse ornata con opere d'ingente valore. Nel riassetto dell'area per far spazio al sontuoso edificio si ricorse alla demolizione di alcuni isolati. I lavori di progettazione, edificazione e arredo della maestosa piazza vennero commissionati ai migliori architetti-artisti dell'epoca tra cui ovviamente non mancarono il Borromini e il Bernini. Pianta di forma rettangolare allungata con al termine, su uno dei due lati più corti, un semicerchio. Fu abbellita da tre fontane e da un obelisco. La particolare geometria della piazza venne ispirata dal precedente circo che sorgeva anticamente al suo posto.
A SLANCIARE VERSO IL CIELO LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
Tra le diverse magnificenze barocche concepite per la realizzazione di piazza Navona, la Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini è senza dubbio il gioiello più prezioso. Il papa affidò l’incarico per la realizzazione a Gian Lorenzo Bernini che gli aveva presentato l'esatta miniatura dell'idea attraverso un modello in argento. Bernini la immaginò sin da subito come una grande scogliera a mo' di bacino di forma ellittica scavato da una grotta a quattro aperture e altrettante statue monumentali rappresentanti simbolicamente i fiumi Danubio, Nilo, Gange e Rio della Plata, con animali e piante all’insegna del movimento e della prosperità. Il tutto a sorreggere un maestoso obelisco col fine di elevare l'opera e il suo insieme verso il cielo.
Innocenzio X rimase folgorato dalla bellezza dell'archetipo e gli diede carta bianca. Magistrale fu la fusione di architettura e scultura, che amalgamò armonicamente il movimento in ogni suo particolare scultoreo, dalla vegetazione, alle statue, alla fauna sulla scogliera. Il componimento di marmo, travertino e granito divenenne il fulcro dell’intero spazio circostante.
Fondamentale fu la riesumazione dell'antico obelisco agonale giacente abbandonato tra le rovine del Circo Massenzio sull'Appia. Fu il pontefice che ebbe la visione che il suo utilizzo fosse il fattore giusto, nella forma e nelle dimensioni, per consentire all'opera del Bernini di essere perfetta. E così lo volle di nuovo a Campo Marzio, dopo secoli di assenza lontano dal Tevere.
Fece trasportare nel cantiere del nuovo «Campus Agonis» i blocchi del gigante disteso e lì nel cantiere di quella che diverrà piazza Navona fece ricomporre in modo perfetto i blocchi di granito al punto di farlo sembrare di nuovo un monolite e lo mise a disposizione del genio di Bernini per il completamento della sontuosa fontana che venne realizzata in tre anni tra il 1648 ed il 1651 da un folto gruppo di artisti e maestranze dirette dal genio partenopeo. Sulla sommità dell'obelisco agonale il papa volle un colomba bronzea, che oltre a essere simbolo della pace, è il volatile presente sullo stemma della nobile casata Pamphili. Non a caso l'obelisco agonale viene anche chiamato dai romani "obelisco pamphilio".
LA LEGGENDA DELLA RIVALITÀ TRA I DUE GENI DEL BAROCCO
La parola ‘rivale’ deriva dal latino rivus «torrente» per meglio dire: «chi vede passare ed ha in comune con un’altra persona l’acqua d’un medesimo ruscello». Ed è così che possiamo definire due geni impareggiabili che vissero nella medesima epoca con la medesima concezione della bellezza. Bernini e Borromini, due rive contrapposte su un percorso comune, verso il quale ognuno aspirò e cercò di farsi largo con ogni visione creativa possibile. Solo nove mesi di differenza d'età, architetti, scultori, ambedue influenzati dal razionalismo illuminista e forte senso della teatralità: napoletano il primo, del Canton Ticino il secondo.
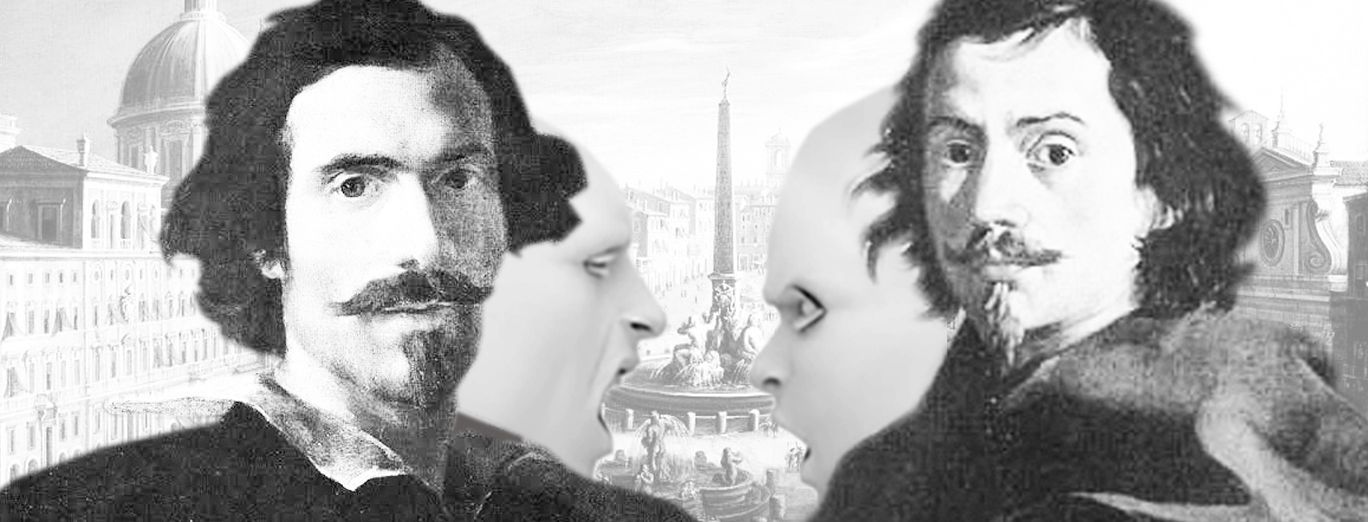
Gian Lorenzo e Francesco riuscirono a detestarsi con una costanza e un’ispirazione quasi ammirevole, osteggiandosi a suon di capolavori artistici. Francesco, con la salita al soglio pontificio del cardinale Fabio Chigi (Alessandro VII) non resse la tensione dell'antagonismo e i morsi della gelosia per gli improvvisi maggiori apprezzamenti pontifici verso il rivale. Fu così purtroppo che l'accesa competività tra i due geni finì con il suo suicidio del bissonese. Stanco di vedere più mondano e amato il rivale artistico, Borromini cadde in depressione e si tolse la vita gettandosi su una spada appoggiata col pomo in terra. Venne sepolto nella basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a piazza dell'Oro nei pressi dell'imbocco in via Giulia, la stessa chiesa dove centoventi anni dopo verrà tumulato anche il marchese Onofrio Del Grillo.
A proposito di ilarità, che suscita il solo nominare il simpatico marchese, c'è una narrazione divenuta "vox popoli romanesca" che strappa un sorriso ogni volta che a colpo d'occhio si guarda la Fontana dei Quattro Fiumi verso la Chiesa di Sant’Agnese in Agone (del Borromini). Questa leggenda narra che la statua del fiume Rio della Plata fa un curioso gesto di protezione col braccio teso e la mano aperta rivolta verso l'opera dell'antagonista, come a temere che la chiesa possa crollare schiacciandolo, mentre il vicino Nilo ha il volto coperto come per non vedere la scena del presunto disastro. In realtà, la fontana è precedente di pochi anni "ma cosa sarebbe la bellezza senza la leggenda?". Le verità rimangono nella pietra e nella storia. In questo caso le raffinate eredità barocche di due geni rivali che ancora oggi questionano attraverso la bellezza e la maestosità dei loro capolavori.