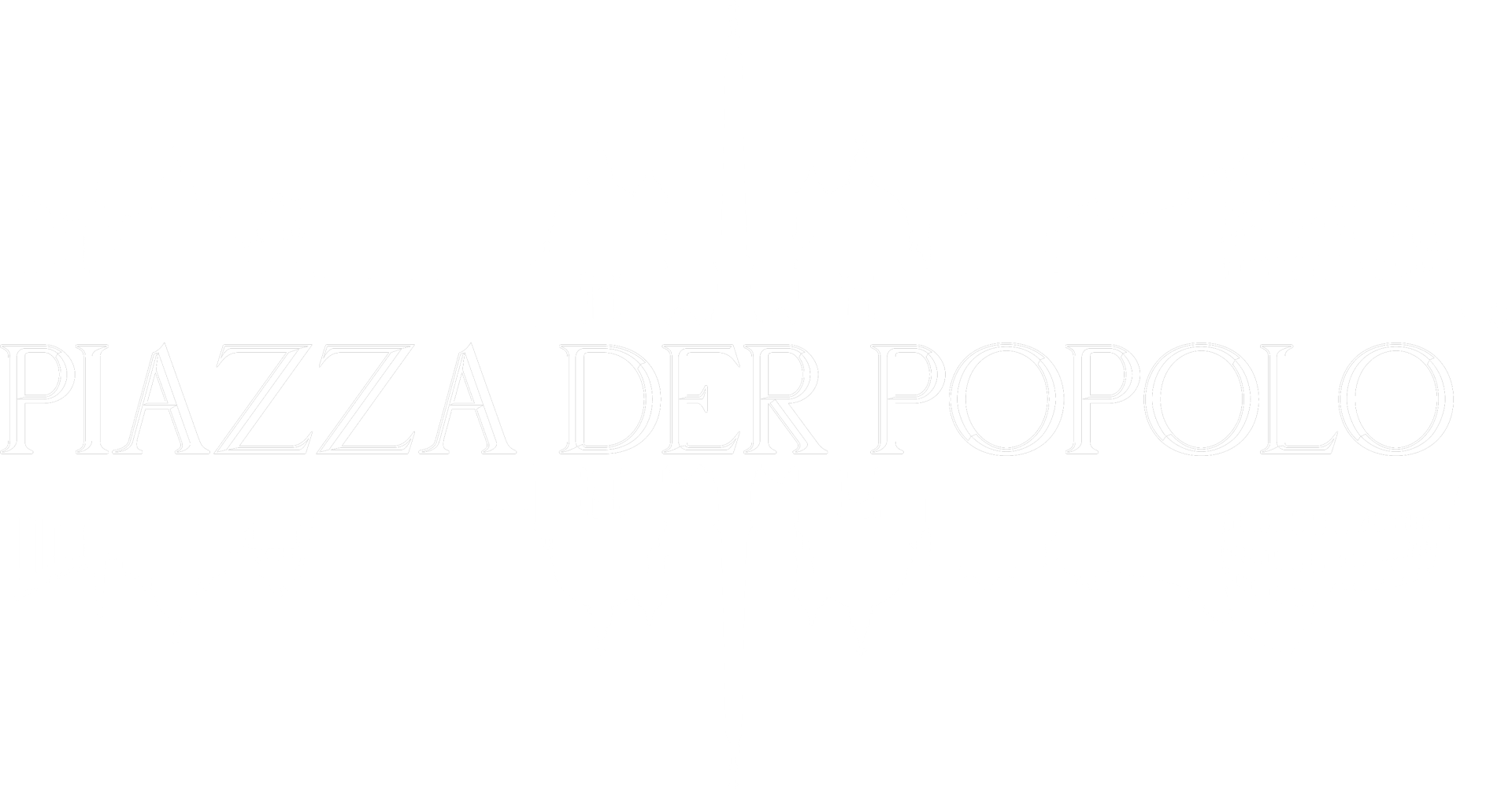IL RIONE MONTI DI COLLE IN COLLE di Domenico Pertica

Monti ha avuto la sua costituzione ufficiale a rione il 18 maggio del 1743 con chirografo di papa Benedetto XIV in base all'opera di revisione urbanistica fatta dal conte Bernardino Bernardini dei dodici rioni medievali, il loro ampliamento a quattordici e l'apposizione di 220 targhe stradali di marmo con il nome e lo stemma del rione. Monti venne spaccato e originò il quindicesimo: l'Esquilino, e da allora assunse le delimitazioni attuali, a parte alcune modifiche tra il 1924 e il 1943, principalmente relative alla zona dei Fori.

Gaius Cilnius Maecenas natcque nel 68 a.C. dall'antica e principesca famiglia etrusca dei Cilnii. L'alto lignaggio e le immense ricchezze influenzarono non poco Augusto. Svolse un ruolo molto importante nella propaganda politica del primo imperatore. Il supporto e l'operato di Mecenate agevolarono enormemente lo sviluppo dell'urbanistica, dell'arte e della poesia di Roma. Tanta fu la sua generosità a l'amore per le arti che il nome di Mecenate è divenuto in tutto il mondo sinonimo di protettore degli artisti. Il circolo intellettuale che Mecenate fondò e finanziò fu il più importante dell'impero e dette ovunque un grande impulso all'arte in ogni sua manifestazione.

Sui Monti esistono tre colli o sommità: Il Laziale, il Nunziale, il Salutare. Il primo sta nel luogo dove si erge la chiesa dei Ss. Domenico e Sisto (Magnanapoli), il secondo dove sorge la villa Aldobrandini (via Nazionale), e il terzo dove si estendono i giardini Colonna (via Ventiquattro Maggio). Più selvaggio di tutti era il Celio, altra cuspide dei Monti, che si chiamava Querquetulanus per i folti querceti che vi si estendevano; il suo nome deriva da Celio Vibenna, condottiero etrusco venuto in soccorso di Roma e di Tarquinio Prisco. Il Viminale si distingueva per le abbondanti piante di vimini e per il tempio dedicato a Giove Viminéo. Sul ventoso Esquilino (così detto da esculus o eschio, albero glandifero sacro a Giove) si riscontrano le cime dell'Oppio e quella del Cispio (dove sorge la basilica di Santa Maria Maggiore); su questo pendio vi era la villa di Mecenate, il cui Auditorium è rimasto in piedi a tutt'oggi davanti al Cinema Brancaccio in via Merulana. Mecenate (Gaius Cilnius Maecenas) fu il bonificatore di questa altura dove si gettavano i cadaveri delle prostitute e degli schiavi, sterminati cimiteri all'aperto sui quali i negromanti eseguivano le loro pratiche magiche. E nel bonificarle eseguì la prima grandiosa e storica lottizzazione a fine speculativo, aprendo l'operazione con quel famoso slogan che sembra dettato da una moderna agenzia immobiliare: «Nun licet Exquilis habitare salubribus!» (È venuto il momento che andiate ad abitare sull'Esquilino dove si respira aria pura!). Poeta egli stesso, trattava gli eruditi con grande splendore; e anche Virgilio e Properzio andarono ad abitare sui salubri colli, insieme ad Orazio, cui il destino riservò il privilegio di essere sepolto in una tomba insieme all'indivisibile amico Mecenate.

Oggi, snodo viario fra più importanti e caotici di Roma, Largo Magnanapoli è, innanzitutto, un crocevia di storie, leggende, luoghi storici, il tutto sotto il velo del mistero, a cominciare dallo stesso toponimo. I Balnea Pauli si dissero volgarmente gli avanzi del Mercato di Traiano e, con molta verisimiglianza, dalla corruzione di questo appellativo derivò, nel secolo VIII quello di Magnanapoli ( Magnus Neapolis Connestabilis), a proposito del quale si racconta come i romani, credendo Virgilio mago, volessero impadronirsi della sua persona in un luogo non lontano da Sant'Agata dei Goti. Ma il poeta, uscito loro invisibilmente di mano si sarebbe rifugiato a Napoli e il ricordo del misterioso caso avrebbe prodotto la volgarizzazione del nome. La chiesa che domina il Largo Magnanapoli è quella di S.Caterina che venne costruita tra il 1628 e il 1641 dall'architetto Giovanni Battista Soria come luogo di culto di un monastero femminile domenicano, le religiose ebbero il permesso di fabbricare la chiesa da papa Urbano VIII.

Estendendosi in antico fino al Castro Pretorio, il rione Monti ricordava da quel lato la difesa armata di Roma imperiale, e comprendeva nella sua cerchia, le fortificazioni di Servio Tullio col famoso Agger Tullianus che si chiamò poi Aggere al Viminale. Nel territorio esistevano ben sette impianti termali: le Terme Diocleziano e, a breve distanza, quelle di Costantino; le Terme di Tito e di Traiano sulle Esquilie, i Balnea Pauli al Quirinale; quelle di Filippo, di Olimpiade e di Novato sul Viminale.
Le Terme di Tito, elevate sui giardini della Domus Aurea dopo la morte di Nerone per cancellare ogni ricordo dell'esecrato tiranno rappresentarono il più efficiente e moderno edificio del genere, e il grande rudere che giganteggia ancora, denominato Sette Sale, significò il serbatoio ad uso dei sottostanti ambienti dei bagni.
Meno ampie delle altre, esse furono elegantissime e ricche di pitture e sculture, e probabilmente, come alla Villa di Livia a Prima Porta, vi si esplicò il genio dei seguaci di Ludio di Etolia che ebbe sotto Augusto gran voga, e portò una vera rivoluzione nella pittura decorativa, abbandonando il disegno geometrico e architettonico, per ritrarre sulle pareti, stanze logge e spalliere fiorite e tutto un nuovo mondo ispirato a libertà fantastica. Raffaello andava cercando al lume delle torce il segreto dell'«encausto» e l'ispirazione sublime ai suoi . «raffaelleschi».


Il rione raccoglie il più vasto patrimonio archeologico della città, dividendolo con il rione Campitelli cui appartiene il Colosseo e con il Palatino cui appartiene il Foro Romano; nonché il primato della scoperta archeologica più famosa della statuaria romana, cioè quel Laooconte rinvenuto nel XIV secolo in una vigna vicina a S. Pietro in Vincoli. Molto del tessuto urbano antico, un intero quartiere medievale, è stato distrutto dal piccone, durante il "ventennio", per farvi scorrere «via dell'Impero». I confini di Monti si estendevano in pratica, oltre questa linea di demarcazione ed era incluso nel rione anche il settore comprendente il Foro di Cesare e il Foro della Pace, la Curia, la Basilica Emilia, la Basilica di Massenzio, e il Tempio di Venere e Roma, nonché le chiese di Ss. Cosma e Damiano, Ss. Luca e Martina e di S.Francesca Romana, che finirono con il Foro Romano e il Colosseo nel rione Campitelli. Ciononostante Monti ha ancora i suoi Fori.
Il Foro Transitorio o Foro di Nerva, servì di passaggio dalla Suburra al Foro Romano. Domiziano lo ideò, vi volle un tempio dedicato a Minerva e Nerva lo completò durante il suo breve regno. Le due colonne esistenti, rimaste a lungo sepolte per due terzi (le cosiddette Colonnacce) appaiono di una estrema eleganza, e il tempio, ancora conservato nel Rinascimento venne demolito da papa Paolo V Borghese per trasportarne le colonne alla grande fontana dell'Acqua Paola sul Gianicolo.
Il Foro di Augusto fu inaugurato nel 2 a.C. con cerimonie solenni, cavalcate guerresche, cacce di leoni nel Circo Massimo, combattimenti di gladiatori. Svetonio ci dice quale fosse la ragione dell'altissimo muro di recensione, perché l'imperatore «fece il Foro alquanto più stretto che non avrebbe voluto, non avendo il coraggio, di espropriare i possessori delle case vicine». La leggenda narra che il quel luogo, in cui sorgeva il tempio di Marte Ultore, si rinvenisse la venerata spada di Cesare. Nell'XI secolo i monaci brasiliani crearono un monastero in questo foro, ed operarono il tempio per le pratiche di culto.
Intorno al 1230 vi si installarono i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme detti successivamente di Rodi e di Malta, i quali sovrapposero un loro edificio, tra una parte dell'emiciclo e il Campo Carléo.
Verso il Quattrocento tutto cadde in rovina, e il Foro fu detto «dei Pantani» per il fango che lo invadeva. E fu in quell'epoca che si procedette ai restauri e totale ricostruzione del complesso armonizzato da una loggia, dalla quale si affacciava il pontefice per la benedizione della folla, riccamente decorata e attribuita a Giuliano da Maiano.
Al Foro di Augusto segue il Mercato di Traiano creato da Apollodoro di Damasco per sostenere il colle Quirinale. Qui sorgeva il grande spazio di vendita e scambio merci dell'Urbe con le numerose tabernae per macellai e artigiani venditori di profumi e di spezie. Undici sono le botteghe del piano terreno e ventuno quelle del piano superiore, cui si aggiungono le altre dell'attico e le taberne della via Biberatica e della grande coperta verso Magnanapoli.
Ma «bello tra i belli» (così fu proclamato da Ammiano Marcellino), è il Foro Traiano. Quando l'imperatore Costanzo, venuto a Roma nel 356 si recò a visitarlo, era in compagnia del principe persiano Ormisda, uomo arguto e piacevole, al quale dichiarava che mai egli avrebbe potuto costruire una simile magnificenza semmai gli fosse stato possibile ordinare una statua equestre in bronzo dorato, uguale a quella di Traiano, trionfante nel centro. Ma Ormisda prontamente osservava: «A che fare un cavallo simile, se non può creargli una stalla pari a questa?». La vasta area si riempì di terra, erbe selvatiche e case, basti pensare che vi sorgeva una chiesa dedicata a San Nicola che aveva per campanile la famosa colonna.

Monti ha l'onore di avere nel suo territorio ben due delle quattro maggiori basiliche: San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore. La basilica lateranense ha origine costantiniana e il suo nome deriva dai Laterani, un'antica famiglia che qui dimorava. All'inizio del IV secolo la proprietà era di Fausta figlia di Massimiano e moglie di Costantino, il quale vi si stabilì dopo la vittoria su Massenzio, ma poi la donò a papa Milziade, edificando da un lato un grandioso tempio cristiano che nell'anno 600, quando Gregorio Magno abitò il Patriarchio Lateranense, venne dedicato a San Giovanni. Varie vicende di costruzioni e ricostruzioni imperversarono su queste mura, fino a quando papa Innocenzio X ne affidò la completa ricostruzione a Francesco Borromini. Capolavoro dell'arte cosmatesca è il chiostro del XII secolo: la parte più antica si deve a Pietro Vassalletti e al figlio di questi. Un edificio isolato che include il Santa Sanctorum, è la Scala Santa meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Sul lato opposto si eleva l'edificio severo che papa Sisto V fece erigere da Domenico Fontana, dove ha sede il Vicariato. L'Ospedale di San Giovanni risale al 1200 quando il cardinale Giovanni Colonna destinava tante case esistenti sul luogo al ricovero degli infermi. Circa un secolo dopo si dava inizio alla costruzione a un maggior edificio nelle cui corsie furono ricoverati gli «appestati» ricordati da Giovanni Boccaccio. Più tardi papa Urbano VIII eresse le sopraelevazioni ancora esistenti. L'obelisco sulla piazza San Giovanni in Laterano, il più alto e il più bello di Roma, ha un'autentica origine egiziana: viene da un tempio di Tebe e fu trasportato a Roma da Costantino che lo destinò a decorare la «spina» del Circo Massimo. Un incendio lo fece crollare e si spezzò in tre. Così giacente rimase fino al 1588, quando papa Sisto V, fattolo dissotterrare diede incarico a Domenico Fontana di elevarlo nel piazzale Lateranense dove l'imperatore Costantino aveva ricevuto il battesimo. Sulla sommità ci sono gli emblemi del papa.

Dall'altra parte di via Merulana, risponde come un eco di gloria squillante dal più alto punto di Monti, la basilica di Santa Maria Maggiore, detta anche Liberiana, che si innalza con il gioco festoso delle cupole del campanile e della fluttuante facciata realizzata da Ferdinando Fuga. Arrivati qui, ripercorrendo via Merulana, siamo passati sopra un tracciato urbanistico arditissimo voluto da Sisto V che, non a torto, dopo Mecenate è da ritenersi il grande «scopritore» dell'Esquilino-Monti, con progetti che se fossero stati del tutto realizzati, avrebbero cambiato totalmente volto alla zona. Davanti a Santa Maria Maggiore sale dalle lontananze del tempo, la nebbia della leggenda. Si dice che nel mese di agosto un giorno nevicò su questa cima che divenne bianca com'ala d'angelo, allora il papa decretò che sul miracolo dell'eccezionale evento metereologico, sorgesse in forma concreta un atto di fede e dunque la chiesa «dedicata alla Madonna della neve». Un'altra leggenda attribuisce al papa Libèrio la prima pietra della chiesa e siamo nel 352: «Liberius» conferma il Liber Pontificalis «fecit basilicam nomini suoi iuxta macellum Liviae». Ma dell'antica fabbrica non restò traccia e l'attuale è dovuta a papa Sisto III (432-440) e si chiamò Sancta Maria ad Praesepe per la tradizione che la vuole custode di una reliquia della culla di Gesù, conservata in una cappella sotterranea. Nell'interno sfolgorano i mosaici dovuti alla scuola di Pietro Cavallini e, il soffitto tutto d'oro di Giuliano da Sangallo; meravigliose le cappelle Sistina e Paolina rispettivamente opere di Domenico Fontana e Flaminio Ponzio.


Altre chiese danno un volto «sacro» al rione. Un angolo di paradiso è il cortile alberato di San Lorenzo in Pannisperna: andatelo a vedere e resterete bloccati, fuori dal tempo per il silenzio che lo avvolge e separa la chiesa da via Panisperna. Qui dove si conserva la «graticola» del martirio del Santo, il 10 agosto c'è gran festa, una festa che dura da mille anni: le monache dispensano a tutti il pane benedetto e tante candele illuminano la magica notte.
Chi potrà raccogliere tutta la suggestione che sale dai silenzi del Convento delle Sepolte Vive in via in Selci, dove si confezionavano le ostie sante delle chiese di Roma?
E la chiesa di Santa Caterina, quasi al riparo della Torre delle Milizie con la celebre Gloria in stucco nel prezioso tabernacolo? Giocondamente dedicato all'amor fedele e alla gioia della vita e a alla grazia degli innamorati, è un angolo della chiesa di San Prassede. L'urna posta sopra l'architrave d'ingresso, racchiude le ossa di San Valentino, protettore appunto degli innamorati. La chiesa è antichissima e sorge sopra la Domus Pudentium, la casa della famiglia senatoriale dei Pudenti, presso la quale dimorò l'apostolo Pietro verso il 40ta dell'era Cristiana. Nella chiesa si conserva anche un rocco della colonna della Flagellazione di Gesù e un quadro di Giulio Romano che ne riproduce la scena. Quasi completamente inosservata, su via Nazionale, è la "basilica paleocristiana" di San Vitale; eppure è un edificio artistico notevole, con il suo portale artistico del primo Rinascimento, e il soffitto a cassettoni e le pitture del Cavalier d'Arpino. È una delle basiliche artistiche della città, fondata come fu nel 401 da papa Innocenzio I probabilmente sul luogo di un tempio romano. San Martino ai monti è uno scrigno segreto di silenzi mistici. Appartiene al titolo «in Equizio» del quarto secolo e papa Silvestro vi tenne un solenne concilio in cui partecipò l'imperatore Costantino. Anche San Clemente risale ai tempi costantiniani, ed è spettacolare la suggestione che sale da questi interni, per le due chiese sovrapposte e la presenza del mistero tutta riunita nel Mitreo, una cella dedicata al culto di Mitra che si era propagata alla fine dell'impero. Calcarono questi venerabili marmi dei pavimenti le pantofole di papa San Zosimo (anno 417) ed anche quelle di Gregorio Magno: i monaci di San Benedetto ne custodiscono ancora il ricordo. La leggenda delle catene di San Pietro ci porta direttamente a San Pietro in Vincoli dove l'imperatrice Eudossia le volle conservare. Papa Giulio II fu il grande artefice dell'attuale architettura sotto le cui volte «parla» ancora nel marmo lunense, il famoso Mosè di Michelangelo.
E che dire della piccola Sant'Agata dei Goti, nascosta come un fiore raro tra la via omonima e via Mazzarino, vicino via Nazionale? Anche qui risaliamo ad epoche leggendarie, al 325 quando fu eretta in un luogo detto in aequo marmoreo; il riferimento «Goti» le viene da quando quel popolo si installò durante l'occupazione di Roma e ne fece il proprio tempio nazionale dove si praticava il culto ariano.

Uno spettacolo a parte del rione, sono le torri, simbolo di un potere baronale che si espresse nel Medioevo. Furono le roccaforti di numerose famiglie. Guardatele in via Giovanni Lanza, a destra e a sinistra della strada: sono le torri dei Graziani e dei Capocci, antiche famiglie guerriere. Poi c'è la torre del Grillo costruita da Marchionne d'Arezzo, dalla quale il famoso marchese gettava le pigne sugli Ebrei e per le strade si cantava: «Salutamo er gueriero der Grillo che gli ebrei a pignate pjò». Grandiosa poi è la torre delle Milizie del XIII secolo i cui piani superiori furono distrutti dal terremoto del 1348; fu dei Conti e dei Caetani e nel 1574 fra i ruderi dell'antico maniero e la torre smozzicata ed inagibile si insediarono le suore di Santa Caterina da Siena. E ancora la torre dei Margani e dei Cesarini detta Borgia, presso San Francesco da Paola. Quella degli Annibaldi lungo la via omonima e proprietà dei Maroniti. Sono queste le ultime testimonianze di un vivaio di torri agguerrite e un tempo inespugnabili nelle lotte cittadine.


Il piano regolatore Viviani della Roma Umbertina fece scempio del «verde» nel rione Monti e così scomparvero la Giustiniana, la Casati e la Altieri, ingoiate dalla speculazione edilizia. Uniche oasi di «verde» sono la Villa Aldobrandini e il parco archeologico del Colle Oppio, ma è ben poco rispetto a una volta. Il taglio moderno del rione venne dalla via Nazionale, la prima strada di Roma capitale aperta per collegare la stazione Termini ai rioni del centro. Il suo tracciato è incluso per due terzi in quello di Monti da Magnanapoli all'incrocio con le vie De Pretis e Quattro Fontane. La sua storia nasce dalla proprietà di monsignor Francesco Saverio De Merode che nel 1867 ne decretò la cessione al Comune di Roma per una parte, fino a cedere dopo il '70 l'altra zona che permetteva di avere un prolungamento dell'arteria progettata e costruita come sede di insediamenti commerciali. Sorse qui la Banca d'Italia dell'architetto Gaetano Kock e il Palazzo delle Esposizioni dell'architetto Pio Piacentini; ma la via ebbe anche palazzine signorili che ne snellirono l'aspetto monumentale che andava assumendo, come la palazzina Hueffer una delle migliori opere puriste del tardo Ottocento. E con il taglio del rione saltò anche il «verde» di cui i «monticiani» andavano orgogliosi. Nel 1774 il Bernardini contava diciassette ville e sette giardini, a parte gli orti e le vigne.
Via Nazionale, da piazza della Repubblica conduce verso piazza Venezia, fermandosi a largo Magnanapoli.
Dopo il trasferimento da Firenze a Roma della capitale del Regno d'Italia, il collegamento tra la stazione Termini e il centro direzionale dell'epoca (via del Corso) fu tracciato seguendo il percorso del romano Vicus Longus, lungo la valle di San Vitale, attraverso una zona che era all'epoca pochissimo abitata, e i cui terreni erano stati acquistati dal monsignor de Mérode proprio nella previsione di questo utilizzo (il rettilineo che percorreva la valle si chiamava "Strada di S. Vitale", e arrivava fino a via dei Serpenti).

La realtà di questo rione è in fondo un'altra: non esiste più l'idea, per un romano che vi abiti, di essere un cittadino specifico dei Monti, proprio perché è venuto meno un concetto delimitato di territorio in seno alla città. Una volta esisteva il «monticiano» con il suo spirito campanilistico registrato in versi famosi: «Sò monticiano, sò sangue de zio! Sò nato pè li monti e me n'avvanto» e con una rivalità inconciliabile verso gli abitanti degli altri rioni registrata negli stornelli: «Sò de li monti e devo fà la guera a li Popolanti. Si vengo giù, perdio, famo li conti». Un avvenimento eloquente sulla bellicosità dei «monticiani» contrapposta a quella dei Trasteverini con la quale spaccavano a metà er core dè Roma, è quella che avveniva al Campo Vaccino (oggi Foro Romano). Vi si svolgeva la famosa «sassaiola» tra i giovani dei due rioni, per stabilire chi fosse il più forte. Campo Vaccino, scriveva il poeta Giuseppe Berneri: «...è un loco for de mano vicino ar Coliseo, poco abitato, indove der bestiame grossolano, ogni otto giorni ce se fà er mercato...». I sassi colpivano sempre e tutti nel segno e dai colpi bisognava schernirsi con il «pietro» o «ferrajolo», o con la camicia e il farsetto durante l'estate. Anche i francesi diu Napoleone I assaggiarono il brivido della sassaiola a Campo Vaccino. Si intromisero nella mischia ma ne uscirono malconci. Per disperdere i ribelli non bastaroni le pattuglie a piedi, ma fu necessario ricorrere a una pattuglia di cavalleria.

Campo Vaccino (oggi Foro Romano) a metà del XIX secolo (foto di Giacomo Caneva)

La sassaiola di Campo Vaccino, battaglia in cui le armi usate erano fionda e sassi